|
Note di medici italiani e francesi sulla pellagra in Valle Brembana
di metà Ottocento
di
Anna Fusco
L'ottocento fu per la Valle Brembana un secolo di gravi carestie e di terribili
epidemie che, oltre ad un alto tasso di mortalità, portò ad un’ondata migratoria
senza eguali.
Numerosi furono inizialmente i casi di tifo petecchiale, ai quali si aggiunsero
ben presto malattie infettive come il colera, il vaiolo, il morbillo, la
varicella, la scarlattina e la difterite, detta anche
mal
del grop.
Vi era poi il gozzo, particolare ingrossamento della ghiandola tiroidea, a cui
spesso si associava l’idiozia e il cretinismo.
Queste malattie, a parte il gozzo che era tipico dell’alta montagna, colpivano
tuttavia anche le città e le aree di pianura, così come quella che si rivelò poi
una vera e propria piaga e che fu oggetto di studi a livello internazionale: la
pellagra.
Il
mal
della rosa,
così chiamata per le macchie rossastre che comparivano su tutto il corpo, si
diffuse nell’Italia centro-settentrionale a partire dalla seconda metà del
Settecento e la causa determinante fu l’alimentazione quasi esclusivamente
basata sulla polenta.
Inizialmente non fu riconosciuta, essendo confusa con lo scorbuto e curata
presso l’Ospedale Maggiore con un antiscorbutico, il succo di un’erba detta
coclearia, la
cardamine asarifolia,
assai frequente nei luoghi umidi delle nostre valli.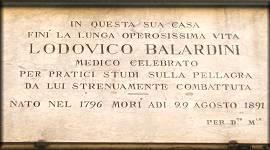 
Poi, nel corso del XIX secolo, prevalse la tesi per cui si attribuiva la
responsabilità dell’insorgenza del morbo al mais guasto, come sostennero
Lodovico Balardini prima e
Cesare Lombroso poi.
Dovuta ad un peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali
conseguente a quello dei patti agrari, che costrinsero i contadini e i poveri a
nutrirsi sempre meno di pane bianco e sempre più con polenta di mais, la
pellagra fu anche definita la malattia delle tre D, in base appunto ai suoi tre
stadi di evoluzione.
La sintomatologia della pellagra presentava, infatti, una
prima fase di dermatite ed eritema (screpolatura delle mani e squamatura della
pelle esposta al sole), seguita da un secondo stadio caratterizzato da
vertigini, debolezza fisica e disturbi gastrointestinali, il cui sintomo
prevalente era la diarrea.
Senza alcun intervento volto a modificare la dieta alimentare,(nota1)
la malattia evolveva infine in demenza e veniva curata con il ricovero
manicomiale, anche se nella maggior parte dei casi portava la morte.
Talmente elevato fu il numero di pazzi pellagrosi che intorno al 1830 si rese
necessario adattare il convento di Astino, ceduto sul finire del ‘700 dal comune
di Bergamo all’Ospedale Maggiore, a manicomio (e lo resterà fino al 1892).
All’epoca, come per molte altre gravi malattie, i medici si divisero riguardo
all’individuazione delle cause della pellagra.
Il medico e fisiologo
Filippo Lussana (1820-1897) si trovò
impegnato “sul campo” ad affrontare la terribile epidemia e ne divenne il
principale studioso. Da semplice medico condotto, si applicò inizialmente allo
studio del morbo a San Pellegrino Terme, dove operò dal 1844 al 1848; studi che
proseguì poi nelle altre valli bergamasche, a Mologno, frazione di Casazza, in
Val Cavallina, e a Gandino, in Valle Seriana.
I risultati delle sue ricerche e delle sue osservazioni furono riportati in
varie monografie, la prima delle quali fu pubblicata nel 1854 con
il titolo
Su la pellagra. Studj pratici del dottore Filippo Lussana.
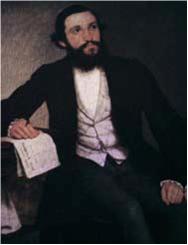 |
|
Filippo Lussana |
Quando Cesare Lombroso, che all’epoca era un monumento rispetto a
Lussana, sostenne che la pellagra era conseguenza di un’intossicazione provocata
da un microrganismo nocivo contenuto nel granoturco, egli non ebbe timori a
contraddire il celebre psichiatra e a dimostrargli che secondo la sua indagine
le ragioni dell’insorgenza della grave malattia risiedevano nel tipo di
alimentazione, ovvero nella dieta estremamente povera o priva di nutrimenti
“plastici” in grado di garantire un apporto sostanzioso ad individui costretti a
svolgere lavori faticosi.
Lo scontro tra i due studiosi fu molto duro e aspro, ma furono molti i medici e
gli scienziati che si schierarono a favore di Filippo Lussana, il quale faceva
della sua esperienza di medico condotto la materia prima dei suoi studi.
Sulla scia delle osservazioni redatte dal celebre studioso bergamasco, furono
condotte negli stessi anni ulteriori indagini, sia da parte di medici italiani
che stranieri, in merito al morbo della pellagra.
Riguardo alla situazione in Valle Brembana, intorno alla metà del XIX secolo il
numero dei malati di pellagra era costantemente
monitorato dai medici condotti dei vari distretti sanitari, i quali erano
invitati, ogni fine anno, a redigere un rendiconto clinico da inoltrare al
Consiglio provinciale sanitario.
A livello, poi, nazionale e internazionale, vi erano dei rapporti
medico-scientifici che prendevano in considerazione diverse
aree; per quanto
riguarda la pellagra, la Valle Brembana risultò essere un campo
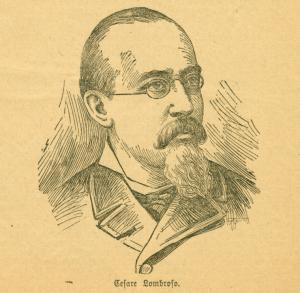 d’indagine
peculiare e dovizioso. d’indagine
peculiare e dovizioso.
Così, per esempio, veniva riportato negli
Annali Universali di Medicina
redatti e
pubblicati nell’ultimo trimestre del 1859 dal Dottore Romolo Griffini, direttore
del Brefotrofio di Milano
(nota 2):
“Volgasi il piede sull’opposto versante meridionale delle medesime Alpi Retiche,
e si entri nella parte superiore delle Valli bergamasche del Brembo e del Serio,
le cui alte montagne si compongono di graniti feldspatici, ardesie e gneis. E
quivi si resta sorpresi di un disinganno inaspettato; più non vi si riscontra
alcuno di quei
cretini sì
frequenti nella Valtellina ed Aosta; estremamente rari vi si osservano anche i
gozzi...
Ma quanto alla pellagra, bisogna
notar bene l’epoca del viaggio che vi si intraprende.
Chi avesse visitato l’alta Valle Brembana ai tempi in cui vi dimorava ancora nel
suo nativo paese l’esimio dott. Marieni,
il quale poi si utilmente studiava la pellagra negli spedali di Milano
(nota 3),
ne sarebbe partito con quella medesima convinzione, colla quale il benemerito
sunnominato medico assicurava il dott. Nardi che nessuno vi soffriva di
pellagra.
Mio suocero, dott.
Testa, il quale per molti anni esercitava la medicina intorno a quell’epoca
medesima nella Valle Brembana superiore, altrettanto mi accertava non esistervi
la pellagra.
Ma coi tempi si cambiarono le cose, quantunque non siensi cambiati i
terreni.
Nel 1829 l’egregio
amico mio dott. Elia vedeva già sui paesi alpestri della Valle Serina (in Valle
Brembana) più matti per pellagra che si veda oggi ubriachi per vino.
In fine del 1854, il mio condiscepolo dott. Regazzoni,
che negli anni anteriori aveva esercitato medicina nell’alta Valle Brembana, mi
assicurava e mi scriveva di avervi veduto molte famiglie pellagrose.
Io stesso, che per tre anni continui dimorai nella Valle Brembana e ne visitai
molti luoghi e ne conversai con diversi medici condotti, vi conobbi non pochi
pellagrosi ed alcuni ve n’ebbi a curare.
E nel medesimo tempo mi assicurai che non vi esisteva alcun
cretino,
e che estremamente rari, più raridi quanto mai avessi veduto in ogni altra parte
di Lombardia, vi erano i
gozzi.
Ciò ripeto onde disingannare chiunque vi guardi e vi cerchi coi propri occhi il
mal asserito cretinismo della Valle Brembana, e come fecero, anche tra i
forestieri, un De La Lande
(nota
4)
e un La Martinière
(nota5),
onde convincersi perfettamente di una verità di fatto che la patria nativa dei
Tasso, di Mascheroni, di Tiraboschi, di Maffei, di Talpino, di Cariani, di
Ceresa, dei Palma, ecc., non era la patria dei cretini e dei gozzuti”.
Alla sorpresa dell’assenza di forme di cretinismo (rivelazione per la quale si
tenne nel 1859 una conferenza a Pavia dal titolo
Intorno al mal asserito cretinismo delle vallate bergamasche)
e alla rarità di gozzi in Valle Brembana, vi fu tuttavia la conferma di numerosi
casi di pellagra, già segnalati negli anni precedenti dai colleghi medici del
Griffini.
Uno studio statistico dei casi di pellagra in Valle Brembana e, in generale, in
Lombardia e nell’Italia settentrionale, fu condotto anche da alcuni studiosi
francesi in due annate differenti, il 1848 e il 1859, pubblicando in seguito i
risultati negli
Annales d’Hygiène Publique et de Médecine Légale
del
gennaio 1861.
(nota
6)
A riportare le osservazioni sui viaggi-studio in Italia fu uno dei principali
studiosi d’oltralpe sulla pellagra, il medico Jean Christian Marc Boudin, che
nella sua relazione
Souvenirs de la campagne d’Italie,
contenuta appunto negli annali menzionati, premette:
“Nos études sur la pellagre datent de 1848, époque à laquelle
nous leur avons consacré un voyage en Piémont et en Lombardie. Pendant la
champagne d’Italie de 1859, nous avons repris ces études, et nous avons visité
dans ce but, les hôpitaux du Piémont, de la Lombardie et de la Vénétie. Non
seulement nous avons vu des centaines de pellagreux, mais encore nous nous
sommes trouvé pendant plusieurs mois en contact permanent avec les hommes les
plus considérables de la haute Italie qui se sont occupés de la pellagre”.(nota7)
Da
una sintesi numerica dei casi di pellagra in Lombardia del 1830, riportata fra
le pagine della relazione di Boudin, risulta che Bergamo e la bergamasca, quasi
a pari merito con la provincia di Brescia, sia con i suoi 6.071 casi una delle
zone della regione maggiormente interessate dal morbo. Questo dato è riportato
(e forse ne fu anche la fonte per Boudin) in un prospetto statistico pubblicato
negli Annali universali di medicina del 1845 dal medico bresciano Lodovico
Balardini all’interno di uno studio intitolato
Della pellagra, del granoturco, quale causa precipua di quella malattia e dei
mezzi per arrestarla.
Il
francese Boudin affianca alle sue successive osservazioni, quelle in merito alla
diffusione della pellagra, agli stadi di evoluzione della malattia e ai rapporti
del più eminente fra gli studiosi italiani, Filippo Lussana, una serie di
statistiche da lui raccolte durante un sopralluogo del 1844 (sua principale
fonte fu l’Ospedale Maggiore di Milano) e che prendono in esame i distretti
delle province di Milano, di Como, e delle valli Brembana e San Martino (si
riporta di seguito la tabella, così come pubblicata nella relazione francese,
dove il numero totale dei pellagrosi è di 263, e non 32 come erroneamente
trascritto).
Si
evince, dal confronto tra le differenti aree, che le valli Brembana e San
Martino detengono una percentuale di pellagrosi di poco inferiore a quella
 |
|
Donna
rovescia la polenta incisione ottocentesca Raccolta Bertarell |
della
provincia milanese, dato gravoso se si mette a paragone il numero degli abitanti
delle due aree, che nelle valli risulta cinque volte inferiore rispetto a quello
dell’area meneghina (sorprende
invece il fatto che i paesi affacciati sul lago
di Como non riscontrino casi di pellagra; la percentuale di seguito riportata si
riferisce in particolar modo ai paesi di campagna distribuiti fra le province di
Como, Varese e Milano):
Provincia di Milano: Popolazione: 412.154 Pellagrosi: 1.589 Perc.: 38,5%
Valli Brembana e San Martino: Popolazione: 80.493 Pellagrosi: 263 Perc.: 32,7%
Provincia di Como: Popolazione: 399.744 Pellagrosi: 686 Perc.: 17,2%
Portando infine a confronto le due diverse testimonianze, quella italiana e
quella francese, si può notare come entrambe riferiscano di un picco di casi di
pellagra intorno al 1830 e come il morbo si mantenne su percentuali elevate
anche a metà secolo.
Basti pensare che, secondo i censimenti provinciali, i
pellagrosi bergamaschi nel 1856 salirono a 8.522 e non si ebbero miglioramenti
neppure negli anni successivi, attestandosi la quota ancora a 8.504 casi nel
1881, risiedenti soprattutto nei circondari di Bergamo e della bassa bergamasca
(in base alla medesima indagine, in Valle Brembana si contavano 393 casi).
Bisognerà aspettare i cambiamenti economici e sociali del primo Novecento per
assistere alla scomparsa definitiva della malattia e, addirittura, al 1938,
molti anni dopo la promulgazione della
Legge sulla pellagra
(1902), basata sulla tesi di Cesare Lombroso, per attestare la fondatezza
scientifica degli studi sostenuti da Filippo Lussana.
_______
nota 1)
La cura che l’ospedale riservava ai pellagrosi consisteva nel miglioramento
della dieta alimentare, resa più varia e completa, nella somministrazione di
alcuni medicinali e nell’obbligo a sostenere bagni o docce refrigeranti e
igienici quotidianamente. Mediamente si curavano 500 malati all’anno, con turni
di ricovero di quindici o venti giorni.
Ritorna al testo>>>
nota 2)
Annali Universali di Medicina, già
compilati dai dottori Annibale Omodei e Carlo-Ampelio Calderini, continuati dal
Dottore Romolo Griffini.
Volume CLXX. Ottobre, Novembre e Dicembre 1859. Milano, presso la
Società per la pubblicazione degli Annali Universali delle Scienze e
dell’Industria, 1859.
Ritorna
al testo>>>
nota 3) Carlo
Nardi : Delle
cause e della cura della pellagra.
Milano, 1836, pag. 137 (nota
dell’autore).
Ritorna al testo>>>
nota 4)
Voyage
en Italie.
Yverdon, 1788, tom.
VII, pag. 266 (nota dell’autore).
Ritorna al testo>>>
nota 5)
Dictionnaire géographique.
Article
Bergamasc
(nota dell’autore).
Ritorna al testo>>>
nota 6)
Annales d’Hygiène Publique et de Médecine Légale,
autori vari, Deuxième Série,
Tome XV, Baillière et
fils Libraires de l’Académie Impériale de Médecine, Paris,
Janvier 1861.
Ritorna
al testo>>>
nota 7) Trad.
“I nostri studi sulla pellagra datano dal 1848, epoca in cui vi
avevamo dedicato un viaggio in Piemonte e Lombardia. Durante la campagna
d’Italia del 1859 abbiamo ripreso questi studi e a tale scopo abbiamo visitato
gli ospedali del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. Non solo abbiamo visto
centinaia di pellagrosi, ma ci siamo anche trovati per molti mesi in continuo
contatto con le maggiori personalità dell’alta Italia che si sono occupate della
pellagra”.
Ritorna
al testo>>>
http://www.culturabrembana.com/quaderni/2007/QuaderniBrembani7.pdf
(vedere da pag. 7-Sommario e da pag 39 in poi l'articolo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Lussana
Inizio Pagina
|