|
Il presente capitolo illustra il carattere e la forte
personalità di Giuseppe Saredo alla base del suo rapporto con i personaggi
politici del suo tempo, nonchè le fasi della sua prestigiosa carriera
pubblica e l'influenza che ebbe nell'orientare la politica italiana della
fine del XIX secolo.
Dell'opera di Ambrogio Casaccia intitolata "Giuseppe Saredo" edita da
Stabilimento Tipografico Editoriale Ricci, Savona 1932
riportiamo
integralmente:
il
Capitolo VIII:
Carattere di Saredo -
Rapporti con grandi italiani - La Questione romana
da pag. 163 a pag. 178
il
Capitolo IX:
Consigliere di
Stato e Senatore
da pag 179 a pag. 200
CAPITOLO VIII
CARATTERE DI SAREDO - RAPPORTI CON
GRANDI ITALIANI - LA QUESTIONE ROMANA
CARATTERE ATTIVO
ED INTEGRO
L'attività di Saredo nella vita politica fu complessa,
continua e instancabile. Iniziatasi a Torino nel 1849, quando apparvero i
primi scritti di lui su fogli liberali di quella città, si protrasse fino al
1902, allorché la morte lo sorprese, affranto dalle fatiche dell'inchiesta
di Napoli.
Raramente egli si concedette tregue o riposi ed amò sempre il lavoro, anche
duro e sfibrante, e s'addolorava ogni volta che il tempo non gli permetteva
di adempiere, giorno per giorno, le molteplici e gravi incombenze cui
s'accingeva o gli venivano affidate.
In una lettera del 22 Dicembre 1898, scriveva all'amico Agostino Cortese:
|
Agostino Cortese
fu sindaco di Savona dal 1884 al 1886 |
«La
mia vita è tale un turbine di occupazioni, che, cominciando dalle 5 del
mattino alle 11 di sera, non riesco a mettermi al corrente».
Questa sua attività non sfuggiva ad alcuno, ed il giornale «Secolo XIX»
di Genova la chiosava argutamente così : «Saredo fa tante cose da una
mezzanotte ad un'altra, che è perennemente l'uomo del giorno».
Nella sua operosa carriera brillò d'un'onestà socratica ed esemplare e nei
suoi atti pubblici si cercherebbe invano un momento in cui abbia deviato
dalla sua rettitudine.
Il savonese grand'uff. Lorenzo Ratto, che visse molto tempo con lui a Roma
ed a Napoli, mi confidò essere stato quegli l'uomo più retto da lui
conosciuto. «Saredo - sono parole del Ratto - avrebbe dato un calcio a un
milione, se questo gli fosse stato offerto per fargli abbandonare la sua
probità».
Forte della sua integrità di condotta, non temette mai gli avversari anche
se ministri o presidenti del Consiglio. Avvenne, anzi, talora il contrario,
ossia che qualche ministro o capo del Ministero temesse Saredo e bramasse
non averlo a incontrare, perchè in lui, Saredo, si riconosceva da tutti,
oltre che l'integro cittadino, uno dei più terribili bollatori e nemici
delle frodi e corruzioni a danno dei Comuni, delle Provincie, delle Opere
pie e dello Stato.
OSTILE ALLE RACCOMANDAZIONI.
Avverso allo spirito arrivista d'una moltitudine d'individui che, privi di
titoli e meriti, tentano salire la scala degli impieghi e delle
onorificenze blandendo, strisciando e adulando, accolse e fece ben di rado
raccomandazioni, e solo e sempre, quando aveva coscienza di non andare
contro giustizia.
Un giorno, che, da tre deputati, gli venne raccomandato di occuparsi di una
persona a lui ignota, egli, prima, volle accertarsi dell'equità della cosa,
scrivendo a un proprio amico Savonese, al quale fra l'altro disse: «Aspetto
la tua risposta, perchè la raccomandazione dei tre deputati non m'importa un
cavolo».
Un'altra volta un prefetto gli si rivolse, con fare supplichevole e
mellifluo, perchè lo facesse creare senatore. Nella lettera, (che se non
fosse umiliante sarebbe un monumento della meschinità in cui piombano gli
uomini in preda alla sete di vanità !) il prefetto non s'accontentava di
enumerare le proprie benemerenze e di dichiararsi superiore ai suoi colleghi
compresi nella lista dei prossimi blasonandi, ma affermava che oramai
aveva accasati i propri figliuoli; che sua moglie preferiva il clima di
Roma a quello di B., ove era prefetto; che da senatore avrebbe potuto servir
meglio l' Italia e che era disposto, (sic.) trasferendosi a Roma, a
frequentare assiduamente le sedute di Palazzo Madama.
Chissà con che risate e ironie Saredo avrà letto un tal documento. Certo che
per Saredo quel prefetto non indossò il laticlavio, nè si mosse da B.
La rigida ostilità di Saredo a fare raccomandazioni apparisce evidente
anche da questa lettera diretta al Comm.
Vittorio Poggi.
Mio caro Poggi,
Ho ricevuto la istanza della signora M..., che tu vivamente mi
raccomandasti. Ma debbo confessarti che io ho per regola assoluta di non
fare sollecitazioni nei Ministeri.
La mia qualità dà capo della Suprema Magistratura amministrativa del Regno
e, quindi, di giudice degli atti dei Ministri e dei Ministeri m'impone la
più generale riserva nelle mie relazioni con loro. E' questa la risposta che
faccio ogni giorno a tutte le raccomandazioni che ricevo per persone o
interessi privati.
I soli interessi che consento a patrocinare sono quelli che hanno carattere
pubblico e in specie quelli della nostra Savona.
Roma, 21 Gennaio 1899.
tuo aff. G. Saredo
DEVOTO AL RE ED ALLO STATUTO
In politica appartenne alla Destra, ma non sdegnò di collaborare con uomini
di Sinistra, non curandosi delle critiche e degli attacchi dei pusilli o di
coloro che fingevano scandalizzarsi.
Rigidamente monarchico e devoto alla Casa Sabauda, frequentava la Corte,
ove eccelleva per la sua cultura e godeva la più grande stima della regina
Margherita.
Della sua fede monarchica feci già diffusamente parola altrove (1), e qui
vi accennerò soltanto riproducendo il seguente tratto della prefazione al
suo libro «Il passaggio della Corona».
«Da questo breve scritto - così Saredo - che (come ben s'intende)
è lavoro di pochi giorni, il solo sentimento che apparirà manifesto da
tutte le pagine, è quello d'una devozione profonda alla Monarchia ed allo
Statuto, sotto i cui auspici, grazie al senno del Re che abbiamo perduto ed
al concorso operoso di tutti i partiti, si è fatta l' Italia».
«Esponendo le dottrine costituzionali, che credo giuste sul «passaggio
della Corona» intendo cooperare in qualche misura a dissipare dubbi ed
equivoci, ad accogliere gli animi e gli affetti intorno alla Dinastia, che è
divenuta una grande istituzione nazionale, che è per l'Italia guarantigia
di sicurezza e di libero governo».
«Casa Savoia ci ha reso un premio ed un servigio assicurandoci l'unità».
(2)
_________________________________
NOTE
1) Vedi p. 99 e 106 di questo volume.
2) Saredo compose il volume «Il passaggio della Corona» in occasione della
morte di Vittorio Emanuele II, pubblicandolo per contribuire alio
scioglimento delle controversie,
cui dava luogo allora, per la prima volta
dopo l'unificazione d' Italia, il trasferimento del potere sovrano.
Nei vari capitoli dell'opera (compilata in pochissimi giorni) sono trattati,
con una poderosa cultura, densa di citazioni di autori italiani, francesi,
tedeschi, inglesi e latini i
seguenti argomenti :
1° - Qual'è il carattere politico e giuridico della Monarchia italiana?
2° - Come si opera la trasmissione giuridica della Corona?
3° - Quali effetti produce per il nuovo Re il passaggio della Corona,
nel'.' Ordine politico presente?
4° - Qual'è il valore giuridico della prestazione del giuramento del Re?
5° - Quali sono gli effetti in relazione alla Nazione?
6° - Qual'è il significato della coronazione?
7° - Quali effetti produce il cambiamento de! capo dello Stato in
relazione ai Ministeri, Parlamento, Autorità giudiziarie e amministrative,
Esercito e Marina?
Il libro, pubblicato nel 1878, apparve, a puntate, anche nella rivista «La
Legge» e venne ripubblicato, nel 1900, nella monumentale collezione di studi
legali, giuridici e
amministrativi intitolata «Digesto italiano» di cui
Saredo fu direttore.
_________________________________
AMICO DI GRANDI ITALIANI DEL RISORGIMENTO
Saredo, avendo vissuto tutto il periodo del nostro Risorgimento e
prolungandosi la sua esistenza fino al 1902, conobbe quasi tutti i migliori
uomini politici che cooperarono all'unificazione e sviluppo d' Italia, ed a
molti di essi fu legato da sentimenti di salda amicizia, che neppure le
idee opposte e i contrasti politici valevano a scemare.
Resi già note le sue relazioni con Cavour (1) per cui ora non vi accennerò
che, riportando il giudizio, espresso da Saredo sul Conte poco dopo la di
lui morte.
Scrivendo degli scarsi seguaci che la scuola liberale ebbe in Italia al suo
sorgere, disse: «Fortunatamente ne ha avuto uno il cui nome valeva un
esercito, ma non è più. La morte di Cavour le ha tolto il più Valoroso dei
suoi esemplari. Le ha tolto colui che grazie all'autorità del nome, grazie
al potente prestigio della sua eloquenza, e alla sua fiducia illimitata
nella dignità della natura umana e nella virile energia del cittadino
italiano poteva meglio di chicchessia far trionfare i principi, che
proclamava con tanta profondità di convincimento a infondere negli altri la
fiducia che egli sentiva». (2)
A pag. 8 dello stesso volume disse che: «la scomparsa di Cavour fu una
catastrofe nazionale perchè morì prima d'aver realizzato il programma che
s'era proposto».
 Relazioni più intime, come il lettore ricorderà, lo strinsero a Mamiani,
Minghetti, Brofferio, Villa, Sella, Correnti, Rattazzi, Ferrara ecc. Relazioni più intime, come il lettore ricorderà, lo strinsero a Mamiani,
Minghetti, Brofferio, Villa, Sella, Correnti, Rattazzi, Ferrara ecc.
Mamiani lo scelse un tempo a suo segretario, gli fece la prefazione alla «Rivista
illustrata», lo nominò professore di Università (3) e Saredo lumeggiò il
valore e le opere di Mamiani in un volumetto. (4)
Minghetti, come palesano alcune sue lettere (5), apprezzò
Saredo non solo come insegnante universitario e maestro di liberalismo, ma
ne sollecitò i consigli e giudizi per la fondazione di giornali e per
l'esame di situazioni politiche; e Saredo, oltre alla compilazione della
biografia del Minghetti (6) ed ai non indifferenti servigi prestatigli, gli
porse un valido sostegno al tempo della battaglia sulla nullità degli atti
non registrati. (7)
|
 Il 27
novembre 1873, il MINGHETTI fece l'esposizione finanziaria, in cui dichiarò
che il disavanzo del 1874 sarebbe stato di 130 milioni, cinquanta dei quali,
e cioè quelli occorrenti per le costruzioni, si sarebbero potuti ricavare
con il credito. Per colmare il disavanzo degli altri 80 milioni il Minghetti
propose quattordici disegni di legge relativi alla tassa sui redditi di
ricchezza mobile, alla nullità degli atti non registrati, all'abolizione
della franchigia postale, all'estensione della privativa dei tabacchi in
Sicilia ecc. Il 27
novembre 1873, il MINGHETTI fece l'esposizione finanziaria, in cui dichiarò
che il disavanzo del 1874 sarebbe stato di 130 milioni, cinquanta dei quali,
e cioè quelli occorrenti per le costruzioni, si sarebbero potuti ricavare
con il credito. Per colmare il disavanzo degli altri 80 milioni il Minghetti
propose quattordici disegni di legge relativi alla tassa sui redditi di
ricchezza mobile, alla nullità degli atti non registrati, all'abolizione
della franchigia postale, all'estensione della privativa dei tabacchi in
Sicilia ecc. |
La questione scottava sia in Parlamento che fuori,
trattandosi d'un argomento toccante da vicino l'essenza dei contratti tra
cittadini.
Saredo pubblicò, in materia, un importantissimo studio, che, a detta di
Boselli, ne rese popolare il nome in tutta la Nazione.
Minghetti, presidente del Consiglio, voleva la votazione della legge. Tomaso
Villa difese, con un poderoso discorso, il progetto alla Camera contro l'on.
Mantellini. Saredo propugnò il medesimo progetto col suo opuscolo nel
paese; opuscolo che gli fruttò, moltiplicata, la riconoscenza di Marco
Minghetti, benché la legge, allora sia rimasta arenata.
Dei rapporti del nostro uomo politico colle altre personalità ora citate,
ad eccezione di quelli con
Urbano Rattazzi, credo d'aver dato nei precedenti
capitoli una sufficiente idea ai cortesi lettori.
Senza ripetere anche per essi, (Rattazzi e Saredo) che si amarono e
stimarono, collaborarono in istessi giornali, si scambiarono corrispondenza
e favori, pubblicherò solo il brano in cui Saredo, a colpi incisivi e
fedeli, tratteggiò e tramandò alla storia la silouette del suo amico
e uomo di Stato alessandrino.
Dopo aver riferito sulla questione della Magistratura e della necessità di
rinnovellarla negli uomini - questione fatta nelle prime sedute del
parlamento piemontese - dice: «In quella discussione spuntava, per la
prima volta, sull'orizzonte politico un avvocato di provincia che si faceva
notare per l'ardore radicale dei suoi principi: uomo di sottile ingegno,
ignaro affatto di scienze civili ed economiche, ma abile parlatore,
giure-consulto peritissimo, devoto alla democrazia, ma ostile alla libertà;
che doveva più tardi occupare grandissima parte nel maneggio dei pubblici
affari e degno, sotto ogni aspetto, della considerazione d'uomo politico
distinto; non fatto per le grandi idee e le grandi cose, ma per comprendere
rapidamente le piccole e condurle al termine con rara fierezza: carattere
integro».
«Tutti hanno riconosciuto in questo ritratto Urbano Rattazzi! ».
«... Il primo discorso di Urbano Rattazzi si distingue per le qualità e
pei difetti, che segnalarono tutti quelli che pronunziò d'allora in poi.
Molta abilità, molte precauzioni oratorie; un sì, seguito da un no ; un no,
seguito da un sì ; un elogio accompagnato da una critica e una critica
accompagnata da un elogio». (8)
___________________________
NOTE
1) Vedi p. 13 e 45 di questo volume.
2) Vedi Saredo: Marco Minghetti p. 9 e 10
3) Vedi p. 46 di questo volume.
4) Vedi p. 61 di questo volume.
5) Sono conservate dalla Marchesa Marieni.
6) Vedi p. 62 di questo volume.
7) Son debitore delle notizie su questo argomento a S. Ecc. Paolo Boselli.
8) Vedi Saredo: Federico Sclopis p. 61 e 62.
____________________________________
RINUNZIA ALL'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO
Uno degli uomini politici con cui Saredo maggiormente s'intese e col quale
si mantenne in diuturna collaborazione cordiale fu però Agostino De Pretis.
Conosciutisi in gioventù a Torino, (1) avevano conservati buoni rapporti,
anche dopo la partenza di Saredo da quella città per Bonneville e Sassari.
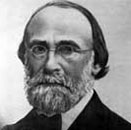 Trasferita
la capitale del Regno a Roma, i loro incontri divennero più frequenti,
perchè Saredo vi dimorava qual professore e De Pretis vi si recava qual
deputato; e da simili incontri, e dalla maggior consuetudine scaturì quella
profonda reciproca stima e leale amicizia, che fece ascendere Saredo a nuove
cariche e onori, e che fruttò a De Pretis, per lunghissimi anni, un
consigliere intelligente e fidato. Trasferita
la capitale del Regno a Roma, i loro incontri divennero più frequenti,
perchè Saredo vi dimorava qual professore e De Pretis vi si recava qual
deputato; e da simili incontri, e dalla maggior consuetudine scaturì quella
profonda reciproca stima e leale amicizia, che fece ascendere Saredo a nuove
cariche e onori, e che fruttò a De Pretis, per lunghissimi anni, un
consigliere intelligente e fidato.
De Pretis, il famoso «uomo di Stradella» già stato più volte Ministro d'
Italia, ne divenne nel 1876 il Capo del Governo, avendo capeggiato la
rivoluzione parlamentare, che, nel Marzo di quell'anno, abbattè e spodestò
la storica Destra.
Fin da quell'anno egli si giovò dell'opera di Giuseppe Saredo, espertissimo
nella scienza amministrativa e giuridica, per diverse pratiche e progetti
legislativi ; e, volendolo collaboratore più assiduo e vicino, nel 1879,
l'invitò a rinunziare allo insegnamento universitario e lo creò Consigliere
di Stato.
Da questo punto la collaborazione di Saredo s'intensifica, diventando
veramente preziosa.
_________________________
NOTE
1) Da notizie confermatemi da S. Ecc. Boselli e dal
senatore Tancredi Galimberti. Agostino
de Pretis, nato il 13 Gennaio 1813 a Mezzana Corti - Bottarone (Pavia) entrò
nel 1848 nel primo Parlamento subalpino, rappresentandovi il Collegio di Broni.
____________________________
COLLABORATORE DI DE PRETIS
In casa Marieni, a Bergamo, si custodiscono, come sacri cimeli, voluminosi
manoscritti di progetti di legge, di esposizioni di bilanci, di discorsi
agli elettori, di circolari ecc., stesi da Saredo per l'amico Presidente del
Governo.
Questi chiamavalo quasi ogni giorno e spesso più volte al giorno presso di
sè, sia a casa che al Ministero, per consultarlo su interpretazioni di
leggi, risposte a interpellanze parlamentari, quesiti di prefetture ed
altre questioni.
A Roma inoltre, i Marchesi Marieni conservano una vera raccolta di biglietti
d'invito e sollecitazioni, testimonianti la brama di De Pretis di ascoltare
i giudizi e pareri del nostro Saredo.
Ecco il tenore di alcuni di tali biglietti.
Caro amico,
Vorrei parlarle in giornata. L'attendo a casa stasera.
Suo dev.mo De Pretis
Caro amico,
Ho bisogno di parlarle. Venga alle 3 al Ministero. Ha terminata la
relazione? Devo presentarla domani.
Suo dev.mo De Pretis
Caro amico,
Desidero vivamente di vederla, avendo molte cose da dirle e grande bisogno
del suo aiuto. Oggi non mi muoverò da casa, e se può Venire da me, mi
troverà a tutte le ore, meno che dalle 2 alle 3, che ho preso impegno con
Correnti.
Mi creda sempre suo dev.mo
19-10-1886.
De Pretis
Tra i progetti di legge più importanti, preparati da Saredo per De Pretis,
ed attorno ai quali consumò notti intere, vanno enumerati quello sullo stato
degli impiegati civili, quello sulla riforma elettorale, quello sulla legge
comunale e provinciale e quello sulla riforma del Consiglio di Stato.
Validissimo aiuto prestò pure all'amico Ministro nella disamina di crisi
politiche e nella formazione dei nuovi Gabinetti.
Eloquente questo episodio, narratomi dal savonese canonico Pietro Poggi,
invitato una sera a pranzo da Saredo in Roma !
Il canonico giunse all'abitazione all'ora fissata, accolto gentilmente dalla signora Luisa. Il marito doveva ancora arrivare. Si attese. Ma il
tempo passava ed egli non compariva. Stanca di aspettare, la signora pregò
il canonico di porsi a mensa. Questa finì, ma Saredo non era venuto.
Il giorno appresso il canonico seppe che Saredo era rimasto fino all'una di
notte in stretto colloquio con De Pretis, studiando la situazione
parlamentare, decidendo lo scioglimento della Camera. Eravamo nel 1880.
Non solo colla sua opera e dottrina Saredo coadiuvò grandemente «l'uomo
di Stradella », ma col suo tatto fine ed oculato, ne seppe modificare
tendenze, frenare impeti e moderare lo spirito cinico e antireligioso. (1).
Nell'intero decennio, che De Pretis tenne, quasi arbitro, le reclini del
potere in Italia, Saredo esercitò su di lui una forte influenza, la quale
dava esca agli avversari di satireggiarlo come l'«alter ego», «l'eminenza
grigia» e «il braccio forte» di De Pretis, e forniva occasione
agli amici di ammirarlo e lodarlo per l'abilità e prudenza con cui volgeva «ambo
le chiavi del cuor» del Ministro. (2)
E siffatta influenza non rimase certamente estranea ai tentativi depretini
d'affrontare la «questione romana».
_______________________
NOTE
1) Come esempio della benefica influenza di Saredo sull'animo di De Pretis,
valga il tratto seguente d'una lettera inviata nel 1929 dal senatore F.
Crispolti alla Marchesa
Teresa Marieni Saredo: «Una notizia di attualità,
essendo ora governatore di Roma il
principe di Piombino. Questo titolo
di un'antica reale sovranità, l'aveva perduto
nel 1883, colla morte del
principe Antonio, bisnonno del Governatore. Infatti il Trattato di Vienna,
incorporando Piombino alla Toscana, aveva conservato il titolo a favore
del
solo principe Luigi, allora vivente, e del suo
primogenito Antonio,
già nato».
«La casa Boncompagni, dolente di non possedere più una qualifica di tanto
onore, si rivolse al Saredo e questi in un batter d'occhio convinse De
Pretis della convenienza
di soddisfarla, e il motu proprio regio non si fece
aspettare.. Ciò benché Rodolfo, nonno del Governatore, primo investito del
titolo rinnovato, appartenesse alla società
nerissima e quindi si tenesse
lontano dalla Corte».
2) Così il senatore March. Filippo Crispolti.
______________________________
LA QUESTIONE ROMANA
La ferita che, colla breccia di Porta Pia, aveva acuito e approfondito il
dissidio tra la Sede Apostolica e la Nazione italiana, sanguinava ancora
viva e straziante al tempo dei diversi Ministeri di Agostino De Pretis.
La
legge delle Guarentigie, votata dal Parlamento italiano nel Maggio 1871,
allo scopo di dare al Papa un compenso per il potere temporale perduto e di
assicurargli — come diceva l'art. IX della medesima — «la piena libertà
nell'esercizio del suo ministero spirituale», non aveva sortiti i suoi
intenti.
Non solo il Pontefice non l'aveva mai voluta riconoscere, ma aveva elevato
ed elevava ogni anno nuove proteste contro di essa, non giudicandola quale
mezzo atto e sicuro a mantenergli la libertà e indipendenza : sul valore ed
effetti della legge esisteva inoltre fra i giuristi, sia italiani che
stranieri, sia cattolici, che acattolici, il massimo disaccordo, e a
dimostrare che tale legge non bastava a provvedere al mantenimento del
rispetto al Papa ed all'inviolabilità dei suoi sacri diritti in Roma,
s'incaricarono la Massoneria e la piazza, inscenando frequenti
manifestazioni di odio al Sommo Pontefice, tentando perfino nel 1881 di
impadronirsi del cadavere di Pio IX per gettarlo nel Tevere. (1)
Nello stesso anno e nei mesi successivi l'oltracotanza delle sette e
l'audacia dei prezzolati o istigati aveva assunto una tonalità sì
minacciosa, che il
Papa Leone XIII non esitò a far chiedere all' Imperatore
Francesco Giuseppe se gli avrebbe offerto ospitalità a Trento o a Salzbourg,
nel caso che, per necessità, avesse dovuto abbandonare Roma. (2)
 E nel 1885, non essendo di molto mutate le condizioni in cui il Papato
trovavasi dal 1870, Leone XIII ribadiva i suoi lamenti e proteste «Mette il
colmo alla nostra amarezza la condizione, fatta qui in Roma, al Vicario dà
Gesù Cristo, la quale quanto più si protrae, tanto più diviene difficile e
dura». E nel 1885, non essendo di molto mutate le condizioni in cui il Papato
trovavasi dal 1870, Leone XIII ribadiva i suoi lamenti e proteste «Mette il
colmo alla nostra amarezza la condizione, fatta qui in Roma, al Vicario dà
Gesù Cristo, la quale quanto più si protrae, tanto più diviene difficile e
dura».
«Nelle presenti condizioni Noi non siamo in poter nostro, ma di altri...».
(3)
E il disagio causato dal perdurare della «questione romana» non si riscontrava in Vaticano soltanto !
E fu forse per questo disagio e per secondare le aure conciliatrici, che nel
1885 spiravano più apertamente, che Saredo e De Pretis volsero di proposito
la mente alla possibilità di sciogliere il nodo della «questione romana».
________________________
NOTE
1) La
salma di Pio IX, deposta provvisoriamente, alla di lui morte, in Vaticano,
dovevasi poi trasferire per volontà del defunto nella basilica di San
Lorenzo al Verano.
Il trasporto avvenne, d'intesa colle autorità civili di Roma, il 13 Luglio
1881. Ma durante il percorso, una schiera di inumani, accecati di rabbia
antireligiosa, assalirono con
pietre e violenze il corteo, scagliando sassi
anche contro il carro funebre e minacciando, se vi fossero riusciti, di
cacciare la salma nelle acque del Tevere.
Questo fatto, degno dei barbari, destò indignazione in ogni parte del mondo
e Leone XIII lo stigmatizzò nell' Allocuzione tenuta al Sacro Collegio il 4
Agosto dello stesso
anno.
2) Vedi la
lettera del
Barone Hubner al
Conte Kalnoky pubblicata dal senatore Francesco Salata a p. 150 del suo volume:
Per la storia diplomatica della
questione
romana.
3) Vedi:
Discorso di Leone XIII al Sacro Collegio tenuto il 2 Marzo 1885.
________________________
TENTATIVI D'ACCORDO
A De Pretis, benché di parte sinistra e poco ligio alla Chiesa, non dovette
spiacere la speranza di passare alla storia coll'aureola di definitore del
conflitto tra Nazione e Papato.
La lunga esperienza di governo e il trovarsi a fianco Saredo, uomo di
destra, gli infondeva ardire, lasciandogli supporre che i tentativi di
conciliazione colla Santa Sede avrebbero trovato largo consenso fra i varii
settori parlamentari.
Trattatosi, pertanto, seriamente fra De Pretis e Saredo della, possibilità
d'un accordo col Vaticano, il secondo benevolo verso il Cristianesimo e il
Papato, (1) incaricò un giovane suo concittadino, il March. Prof. Alessandro
Corsi, di preparare uno studio sulle condizioni della Santa Sede nei
rapporti del diritto internazionale e del diritto pubblico italiano.
Simile studio sarebbe stato poi estesissimamente diffuso in Italia, dovendo
servire di spunto a discussioni, proposte ed approcci.
Il Corsi compose ben presto il suo lavoro, che apparve, nei primi mesi del
1886, ne «La Legge», diretta da Saredo e nella quale il Corsi collaborava.
(2)
Questi divise la sua trattazione in tre parti, dimostrando nella prima che
la Santa Sede, anche senza il potere temporale, non poteva paragonarsi e
confondersi con una confessione religiosa qualsiasi, essendo
un'organizzazione sui generis, dotata dei costitutivi di persona giuridica
internazionale e come tale riconosciuta da popoli e governi. Nella seconda
parte, sostenne che la stessa legge delle Guarentigie riconosceva al Papato
la personalità giuridica internazionale, provandolo:
1°, colla facoltà che
avevano i governi stranieri di richiamare l' Italia allo adempimento dei
suoi impegni;
2°, col diritto della Santa Sede alla Legazione attiva e passiva;
3°, col potere della medesima Santa Sede di fare concordati e
trattati coll'estero, anche in materia non prettamente spirituale.
Nella
terza parte, considerando la legge delle Guarentigie relativamente all'atto
della capitolazione di Roma, firmato a Villa Albani il 20 Settembre 1870, ed
al diritto pubblico italiano, concludeva che il Papa risultava, tanto da
detta legge che dal diritto, non solo un sovrano onorifico, come voleva il
Bonghi, ma un vero e proprio sovrano con suo territorio. (3)
L'opera del Corsi, che venne pubblicata pure in fascicoli, ebbe un'eco assai
vasta nella stampa e fra gli studiosi di scienze giuridiche.
Il piano stabilito da De Pretis e Saredo comprendeva, oltre gli studi e
discussioni sulla stampa, varii altri mezzi, non ultimo quello di iniziare,
da parte del Governo, una politica di aperto favore verso i Missionari
cattolici all'estero.
Proteggendo e sostenendo le Missioni, il Governo (nella mente dei due uomini
politici) avrebbe fatto intendere all'opinione pubblica che lo Stato non
odiava nè trascurava la Chiesa, ma che era benevolmente disposto a riguardo
di essa, e da canto suo la Santa Sede non avrebbe potuto restare sorda e
impassibile a ciò, che lo Stato faceva per gli Apostoli del Vangelo in
terre lontane.
L'aiutare le Missioni e il largheggiare con esse si presentava quindi come
il sentiero più facile, su cui la Santa Sede e l' Italia avrebbero dovuto
incontrarsi e incominciare ad intendersi per arrivare alla fine del lungo
dissidio.
Agli intenti e preparativi della buona battaglia, non corrispose allora il
frutto sperato, perchè la morte strappò, poco appresso, al Governo Agostino
De Pretis. (4)
Ma se l'avvenimento, sognato dal Ministro e dal suo collaboratore, rimase
per essi e per moltissimi altri uomini politici a loro succeduti una
semplice brama e speranza, ora invece, per la concorde e tenace volontà di
Pio XI e di Benito Mussolini, è un fatto compiuto, apportatore di
pacificazione, gloria e grandezza alla Chiesa e alla Patria. E nella storia
dei Patti del Laterano, il nome di Saredo non sfigurerà certamente tra
quelli dei vati e precursori della Conciliazione.
______________________________________
NOTE
1) Ai molti passi già riportati
nel capitolo
«Benemerenze di Saredo verso le Religione» dimostranti la deferenza e rispetto di Saredo verso la Chiesa Cattolica,
aggiungo i
seguenti concernenti più specialmente la
questione romana.
«Nella costituzione della vita politica italiana, bisogna tener l'occhio a
tre grandi fatti: la religione cattolica ed il Papato; la condizione
geografica; le tradizioni storiche delle
varie Provincie».
(Dai «Principi di diritto costituzionale»
vol. IV p. 216).
Discorrendo poi più particolarmente del problema del Papato scrive: «vi
confesso, o Signori, che questo problema non mi sgomenta. Lo spirito
giacobino che regna tuttora
in Italia, ci ha allontanati fin qui dalla
retta soluzione: il giorno in cui ci saremo educati a
sensi più sani di giustizia e di libertà, allora anche la
questione del Papato avrà
ottenuto la sua soluzione».
«Due funeste opinioni guastano, a mio parere, la politica nazionale su
questo punto: — l'una che gli italiani hanno diritto di reclamare e di aver
Roma — l'altra che il
Governo ha il diritto di adoperare la forza contro ciò
che si chiama esorbitanze clericali —».
«Non
è vero, in nessun modo, che gli italiani abbiano diritto di
avere Roma. Forse che Roma è una proprietà fondiaria stata loro tolta? No,
per fermo.
Roma è un territorio abitato da esseri liberi e intelligenti; da uomini i
quali soli hanno diritto di decidere il loro destino...».
«Più grave assai è il secondo errore. Che dico errore? vorrei dirlo delitto
: — Singolar cosa! si urla ad ogni piè sospinto che si vuole libertà di
coscienza, libertà di culto: e
intanto si arrestano Vescovi e preti, si
fanno loro processi inauditi per aver stampato una circolare, pubblicato
un' Enciclica, parlato con rispetto del Pontefice...».
«Che dice il Papa? Che dicono di lui i difensori del potere temporale? Essi
ripetono che senza potere temporale il Capo della Chiesa cattolica sarebbe
legato nell'esercizio
delle sue attribuzioni pontificali; e che cessando
d'essere sovrano-territoriale dovrebbe ubbidire nelle cose religiose come
nelle cose civili...». «A
queste giuste, nobili e
sante preoccupazioni che rispondono i nostri
pubbìicisti, i nostri uomini di Stato, il nostro Parlamento?».
«Rispondono coll'imprigionare e processare Cardinali, Vescovi, preti rei non
d'altro che d'aver adempiuto i doveri del loro posto: rispondono con
minacciare leggi e pene
più severe contro tutti gli Ordini del Clero...»
(Dai
«Principi di diritto costituzionale»
vol. IV p. 218 ecc.).
E conclude che non è questo il
miglior modo di dimostrare al Papa che gli sarà garantita pace e
tranquillità qualora ceda il
potere temporale (vedi idem).
2)
Il March. A. Corsi lesse questo suo lavoro, come prolusione al corso di
diritto internazionale, da lui svolto all' Università di Macerata nell'anno
1885-86.
3)
Questa terza ed ultima parte assume oggi una notevolissima importanza,
perchè da essa appare che Saredo e Corsi furono precursori del Trattato del
Laterano del 1929.
Essi
infatti sostenevano fin d'allora, contro il Brusa, il
Bonghi e mille altri
che il Papa in Vaticano era vero sovrano in territorio proprio. Vero
sovrano; non di nome
soltanto
o ad honorem. Vero sovrano
in territorio proprio e non semplice usufruttuario, perchè il Vaticano, in
omaggio alla Convenzione dei generali Cadorna e Kanzler,
non era mai stato
occupato dalle truppe italiane, ed il Papa era vero Sovrano nonostante
l'esiguità del territorio rimastogli, nel quale poteva tuttavia fare leggi,
ricevere e
spedire ambasciatori, provvedere all'amministrazione interna ed
avere corpi armati. (Da un mio articolo sul giornale «Il Letimbro» di Savona
del 1 Marzo 1929 ; articolo
intitolato «Due
Savonesi
e
la questione romana».
4)
Morì, presidente dei Ministri a Stradella il 29 Luglio 1887.
___________________________________________
*****
Inizio Pagina
Capitolo IX
CONSIGLIERE DI
STATO E SENATORE
DA CRITICO A
PRESIDENTE
Due punti delle numerose pubblicazioni dell'on. Saredo
riflettono il suo pensiero circa l'utilità e il funzionamento del Consiglio
di Stato. Dal
primo di essi (1) traspare che, nei primordi del suo insegnamento alle
Università, l'autore non nutriva soverchie simpatie per quell'alto Consesso,
istituito nel 1831 da
Re Carlo Alberto, per funzionare da
organo collegiale permanente allo scopo di dare pareri e pronunziare
sentenze in materia amministrativa. Dal
primo di essi (1) traspare che, nei primordi del suo insegnamento alle
Università, l'autore non nutriva soverchie simpatie per quell'alto Consesso,
istituito nel 1831 da
Re Carlo Alberto, per funzionare da
organo collegiale permanente allo scopo di dare pareri e pronunziare
sentenze in materia amministrativa.
Saredo, infatti, designava allora il Consiglio di Stato come
una anomalia portante confusione negli uffici del potere legislativo e di
quello giudiziario e dimezzante la responsabilità degli agenti della
pubblica amministrazione.
Nel secondo punto (2) - siamo al 1895 - le critiche a quella
importante istituzione scompaiono ed essa viene trattata coi riguardi dovuti
ad uno dei magni organi della Nazione.
Il radicale mutamento di giudizio, si basava in modo
particolare sull'esperienza che Saredo, quale membro del Consiglio medesimo,
aveva fatta della importanza di questo e dei vantaggi che da esso
provenivano sia ai cittadini, che alla pubblica cosa.
Come si disse, egli entrò in quell'onorifico e gravoso
uffizio nel 1879, elettovi da Agostino De Pretis, e vi portò tale cultura
giuridica, competenza amministrativa, sagace criterio e lena operosa da
farlo presto eccellere sopra colleghi più anziani e farlo creare, in poco
più d'un decennio, presidente di una delle quattro sezioni ed, in seguito,
presidente generale del Consiglio stesso.
__________________________
NOTE
1) Vedi Saredo: «Principi di diritto costituzionale», vol. IV p. 124.
2) Vedi Saredo: «Codice delle Amministrazioni».
__________________________
UNA PERIPEZIA DI R. BONGHI
Per non incorrere in ripetizioni, ridurrò il mio dire, sull'opera
di Saredo nel Consiglio di Stato, al periodo che egli ne tenne la
presidenza.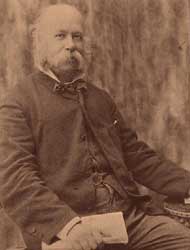
Non voglio, però, tacere al cortese lettore un significativo
episodio, successo nel 1893, dal quale emerge, oltreché l'influenza di
Saredo nell'importante Consesso, anche la sua tempra di amico e la
scrupolosa rettitudine di
Ruggero Bonghi - identico in ciò a
Saredo - verso il pubblico erario.
L'on.
Antonio Boggiano Pico e la March.
Teresa Marieni-Saredo
mi ricordarono, più d'una volta, la sincera cordialità, che correva fra il
nostro Saredo ed il patriota, filosofo, letterato, giornalista e uomo
politico Ruggero Bonghi.
Costui si vedeva spesso assieme a Saredo per le vie di Roma,
in caratteristico gruppo: l'uno e l'altro in tuba e frac nero, con fronte
spaziosa e viso inquadrato da folta barba alla chantillón; Saredo alto,
tarchiato; Bonghi basso, tondo; camminando affiancati, destavano qualche
sorriso, perchè formavano l'articolo « il » ambulante.
La loro amicizia, grande anche prima, s'era accresciuta nel
1870 (anno in cui pure il Bonghi assunse una cattedra alla «Sapienza» di
Roma) ed aveva rifulso nel 1893.
In questo anno, scrivendo sulla «Nuova antologia», il
Bonghi aveva introdotte alcune frasi punto lusinghiere per una delle più
eminenti personalità della Nazione.
Lo scritto aveva provocato meraviglie e scalpori; da molte
parti d' Italia s'erano invocate punizioni ed emende nei riguardi dello
Scrittore; e l'eco delle proteste, ripercossa pure nel Consiglio di Stato,
vi aveva scatenato un tale divario d'umori da indurre il Bonghi ad astenersi
dal frequentare il Consiglio, di cui era membro, e a determinare il
Consiglio stesso a sottoporre il colpevole a un particolare processo per
esaminare se fosse il caso di espellerlo da Palazzo Spada. (1)
Tra i giudici era compreso Saredo e il processo si svolse. La
sentenza fu di assoluzione per Bonghi.
E il merito di essa - come appare dal seguente brano di
lettera - spettò principalmente al Saredo.
Caro Saredo,
..................................
Vi ringrazio della parte presa nel processo fattomi al
Consiglio di Stato.
Non aspettavo tanto dal retto giudizio vostro e dall' amicizia che avete per
me. Ora mi pare che la sentenza mi rende doveroso di prendere parte alle
riunioni del Consiglio, dalle quali mi era tenuto lontano in questo
intervallo di tempo, per consiglio Vostro.
Però mi è molto doluto ch'io dovessi prendere lo stipendio a ufo, senza far
nulla. Perciò vi prego di volermi mandare degli affari da studiare e mi
permetto di aggiungere che più saranno difficili e complessi, più Ve ne sarò
grato.
..........................................
Amate il Vostro
Bonghi.
Roma, 19 Marzo 1893.
Saredo aveva salvato l'amico e questi riconoscente, rientrando in seno al
Consiglio, pregava il suo salvatore a procurargli lavoro - e lavoro pesante
! - onde poter reintegrare lo Stato del denaro che da esso aveva percepito
anche quando non gli aveva prestato servigio alcuno. (2)
__________________________
NOTE
1) Vi ha sede il Consiglio di Stato.
2) L'originale della lettera è posseduto dalla Marchesa Marieni.
____________________________
PRESIDENTE GENERALE
|
La IV Sezione del Consiglio di Stato è
istituita con legge 31 marzo 1889. Il cambiamento si presenta notevole,
perché oggetto della tutela giurisdizionale non è più esclusivamente il
diritto soggettivo, ma viene ad affacciarsi la figura dell'interesse
legittimo, figura atta ad assicurare una più piena (o quantomeno più estesa)
tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
La teoria delle "sfere separate", la rigida teorizzazione della separazione
dei poteri cominciano così a lasciare il posto ad una tutela, nei confronti
della pubblica amministrazione, più piena soprattutto verso i poteri
discrezionali da questa esercitati; il sindacato della IV Sezione del
Consiglio di Stato ha infatti come oggetto l'esercizio del potere
discrezionale e viene pertanto in rilievo per la prima volta un vizio degli
atti amministrativi, l'eccesso di potere, visto, per altro, non più nella
sua nozione originaria (come incompetenza assoluta), ma come «scorretto
esercizio del potere discrezionale», affiancantesi ai già sindacabili vizi
di violazione di legge e di incompetenza assoluta.
http://www.tesionline.it/news/cronologia.jsp?evid=4747 |
Alla nomina di Saredo a presidente di Consiglio di Stato, il
marchese Crispolti commentava: «Per una Volta il ministero ha avuto la mano
felice! E scegliendo l'uomo ch'era indicato dai suoi meriti e dall'aver
presieduto la IV Sezione, ha risparmiato a quel corpo l'onta di scegliergli
un capo dal di fuori, come consigliavano coloro che avevano fatto i nomi
di…». (1)
Morto, sul principio del 1898 lo storico e senatore
Marco Tabarrini, che teneva la
Presidenza del Consiglio di Stato dal 1891, i prognostici circa il suo
successore s'aggiravano sui nomi dei sen.
Gaspare Finali,
Giovanni Codronchi, Giuseppe Saredo e
di pochi altri. Ma, al 23 Gennaio, un annunzio ufficiale, comunicava, tra il
generale consenso, che a presiedere la massima Istituzione amministrativa
italiana era stato assunto il Saredo, il quale, al 2 febbraio, s'insediava a
Piazza Capo di ferro (2) per disimpegnare l'ufficio, in cui l'avevano
preceduto
D' Ambrois e
Carlo Cadorna.
________________________
NOTE
1) Vedi il giornale a «Il Cittadino di Genova»,
in uno degli ultimi giorni del Gennaio 1898.
2) Su questa piazza sorge il Palazzo del
Consiglio di Stato.
_________________________
UOMO FATTIVO E DINAMICO
Uomo fattivo e dinamico, Saredo, rivestito della nuova
dignità, non si beò sonnecchiante sugli allori ottenuti, ma si accinse alla
novella fatica coll'ardire e l'ardore d'un giovane, imprimendo ai Consiglio
di Stato una vita più rigogliosa e apprezzata e sfatando la leggenda che
Palazzo Spada fosse un rifugio per vecchi o una prebenda per giubilati.
Se le elaborate relazioni, pareri e sentenze stese da Saredo
nei primi anni di suo consiglierato e conservate negli Archivi di quella
suprema Corte amministrativa, rimarranno documenti preziosi del di lui
valore e rapacità; le relazioni, pareri e decisioni, non meno dotte e
ponderate, che tracciò da presidente generale, resteranno documenti
imperituri della sua straordinaria attività. E perchè? Perchè a differenza
di altri presidenti, scriveva egli stesso relazioni e pareri, e lavorava
come uno scrupoloso impiegato.
Lavorando egli, voleva però che non stessero inerti nemmeno gli altri,
fossero consiglieri o semplici impiegati.
A proposito di che, il Marchese Crispolti pubblicò: «Egli
non vantava mai il suo ingegno, ma vantava il suo amore per il lavoro e la
sua improba costanza in esso... Mentre era assai equo verso le varie
attitudini intellettuali e opinioni della gente, era implacabile verso gli
uomini molli. In qualunque circostanza egli avesse dovuto o potuto cercarsi
collaboratori per uffici alti o minori, respingeva inesorabilmente quelli
che avevano poca volontà di lavorare...». (1)
Nonostante una sì grande esigenza che tutti compissero il
dovere imposto dalle cariche o dagli impieghi, egli era ben viso da tutti,
colleghi e dipendenti, perchè non oziava, ma dava magnifico esempio di
diligenza e operosità.
Espressive, al riguardo, sono le parole d'un vecchio barbiere
di Roma, che prima di darsi all'arte di Figaro, aveva fatto l'usciere al
Consiglio di Stato, sotto Saredo. «Saredo - ripeteva il barbiere - ci faceva lavorare, ma gli volevamo
bene ed eravamo contenti, perchè egli lavorava per il primo e doppiamente di
noi».
«Saredo - ripeteva il barbiere - ci faceva lavorare, ma gli volevamo
bene ed eravamo contenti, perchè egli lavorava per il primo e doppiamente di
noi».
Egli accrebbe davvero - come mi notarono gli on. Boselli e
Schanzer - il prestigio del Consiglio di Stato sia ostacolando l'ammissione
ad esso di membri inetti e di poco rendimento (2), sia introducendovi un
ritmo di più rigorosa giustizia (3), sia rendendovi meno spaventosa l'idea
religiosa e sia sfrondando da inquinamenti settari l'ambiente.
Ebbe assai eco, in fatto di tale giustizia e inquinamenti
settari, l'affare di certi contadini bresciani, consiglieri comunali di **.
Essi militavano nelle file cattoliche e il segretario comunale odiava il
profumo d'incenso. Tra l'uno e gli altri non tardarono ad accendersi
contese, per le quali occorse adire il Consiglio di Stato. Si era verso il
1901.
Il segretario comunale si pose sotto il patrocinio dell'anticlericalissimo
Zanardelli, allora presidente dei Ministri; i consiglieri cattolici
s'affidarono a un bravo avvocato.
La conclusione fu: torto al segretario; ragione ai
consiglieri. Zanardelli, che s'aspettava ben altro, si meravigliò con
Borromini Galleria di P.Spada
Saredo in una melanconica lettera,
esprimendo l'augurio che non si emettessero giudizii consimili in avvenire.
Ma Saredo, tetragono ad ogni pressione, specialmente se ingiusta, non si
scompose o umiliò. Ciò che gli premeva era che il parere del Consiglio di
Stato rispondesse a giustizia; e vi rispondeva. Che il segretario fosse
anticlericale o meno non doveva interessare il Consiglio di Stato. Se il
segretario aveva torto, ne l'anticlericalismo, nè Zanardelli poteva fargli
dare ragione.
Ed allo stesso modo che, per seguire i dettami della
giustizia, non curò le pressioni di Zanardelli, così non piegò a lusinghe e
ingiuste istanze di altri.
Si studiò, invece, di vagliare sempre a fondo le cause e di raccogliere la
maggiore abbondanza di prove, non ricusando - sempre in nome della giustizia
- di ritornare sui propri pensieri e giudizi e - come tosto vedremo - di
superare prevenzioni e antipatie.
_________________________
NOTE
1) Da un articolo del March. Filippo Crispolti, pubblicato nel «Cittadino
di Genova», nei primi giorni del Gennaio 1903.
2) Il marchese Crispolti, alludendo a ciò,
scriveva: «...figuratevi come dovesse contrastare per i posti di
consigliere di Stato, considerati per molto tempo come un canonicato
da
conferirsi a personaggi inerti e decorativi !». Dal «Cittadino
di Genova», gennaio 1903.
3) Saredo suggerì, nel suo volumetto sui doveri
dei Prefetti, riforme che oggi vennero attuate: e da Presidente del
Consiglio di Stato, più d'una volta, pretese che dai prefetti
si
osservassero quei doveri, che egli aveva sì bene tracciati.
A Roma un ex prefetto mi raccontò che un suo
collega, per scampare dalla inflessibilità di Saredo, dovette ricorrere alla
Regina Margherita ed a più deputati.
____________________________
L'AMICIZIA DI SCHANZER
Carlo Schanzer, triestino (nato nel 1865) celebre avvocato,
professore di diritto costituzionale all' Università di Roma, senatore
 ed
ex Ministro del Regno, venne nominato a 28 anni referendario al Consiglio di
Stato ed assunto alla IV Sezione. ed
ex Ministro del Regno, venne nominato a 28 anni referendario al Consiglio di
Stato ed assunto alla IV Sezione.
Agli esordi di questo suo ufficio non godette la più
espansiva benevolenza di Giuseppe Saredo.
Essendo questi avversario implacato di Giovanni Giolitti,
sentiva quasi spontaneamente una sfavorevole disposizione verso lo Schanzer,
sapendolo amico di Giolitti.
Col fatto sembrava che Saredo ripetesse: «Chi è amico del mio
nemico, non può essermi amico».
Lo Schanzer, però, non era divenuto referendario perchè amico
di Giolitti, ma perchè era riuscito primo nel Concorso, indetto per il
conferimento di quel posto nel novembre 1892. E il Concorso, in quell'anno,
non si presentò facile come il cogliere rose in aiuole, perchè lo
presiedeva quel
Silvio Spaventa, che non infondeva certamente coraggio.
Saredo pertanto non indugiò molto ad ascoltare la voce della
giustizia ed a seguirla.
Il neo referendario pieno di attività e intelligenza eseguiva
le sue mansioni con diligente e straordinaria perizia: ed un giorno che
Saredo, allora presidente dell'alto Consesso, lesse ed esaminò una relazione
preparata da Schanzer esclamò: «Queste sono relazioni che potrebbero essere
firmate dai più vecchi ed abili consiglieri di Stato. Nominerò presto
Consigliere lo Schanzer». (1)
L'antipatia s'era mutata in stima ed ammirazione per
convertirsi, grado grado, in cordiale amicizia.
Fedele alla sua parola, Saredo propose la creazione dello
Schanzer a Consigliere di Stato e nel luglio del 1898 poteva scrivergli :
Roma, 4 Luglio 1898.
Egregio e caro collega,
L' ufficio di Presidenza del Consiglio di Stato nel proporre
a più riprese al Governo del Re la di lei nomina a Consigliere, ha voluto
testimoniare la sua piena soddisfazione per il servizio che da molti anni
ella presta a questo Consiglio.
Il reale decreto che ha accolto la proposta è stato perciò
considerato come un atto di giustizia, ed io me ne rallegro con lei e ne vò
orgoglioso per questo Consiglio.
Mi creda sempre suo
G. Saredo.
Contribuì a rinsaldare la loro amicizia un atto di squisita
lealtà di Saredo.
Me lo palesò lo stesso on. Schanzer il giorno, che recatomi
alla sua villa di Roma (2), per pregarlo di alcune notizie sull'opera di
quegli al Consiglio di Stato, non solo mi diede la massima parte di quelle
da me pubblicate finora in questo capitolo, ma con cortese signorilità me
ne fornì e confermò molte altre sul di lui valore scientifico e intelligente
attività qual professore, giurista e senatore.
E in che consistette quell'atto leale? In ciò. Quando
l'onorevole Schanzer si fidanzò colla signorina Corinna Centurini, i
parenti di essa domandarono confidenzialmente a Saredo il suo giudizio sul
fidanzato. Saredo lo pronunziò lusinghiero sotto tutti gli aspetti. Il che
piacque tanto allo Schanzer, che lo indusse a scegliere Saredo per
testimonio nel dì delle nozze. (3)
Quasi a ratificare i sensi di sincera cordialità
trascorsi fra loro, l'ex Ministro, congedandomi dopo il non breve colloquio,
stringendomi la mano mi disse: «La ringrazio, reverendo, perchè oggi mi
diede occasione di ricordare uno dei miei amici più cari».
________________________
NOTE
1) Attinsi queste notizie da S. E. Boseili e dal Grand' Uff. Lorenzo Ratto,
cui le aveva confidate lo stesso Saredo.
2) Nel Gennaio del 1929.
3) Riporto la lettera con cui Saredo risponde ai novelli
sposi Schanzer-Centurini, che dal viaggio di nozze gli avevano rinnovati i
ringraziamenti per essere stato loro
testimonio.
Mio caro Schanzer,
Ho tardato a rispondere, perchè quando ricevetti la sua
lettera, aveva già lasciato Zermatt per intraprendere le peregrinazioni che
mi annunziava; e posto che ella s'era
prefisso di trovarsi a Lucca per la
fine di agosto, pensai di attendere a scriverle quando fossi certo che la
mia le sarebbe giunta con sicurezza.
Quanto io sia stato suscettibile al pensiero suo non ho
bisogno di dirglielo: ella lo può immaginare pensando quanta sia la stima,
e quanta l'amicizia che professo per lei.
Grazie dunque della sua lettera carissima, e voglia esprimere
la mia gratitudine alla sua graziosa intelligente signora, per essersi
voluta associare ai saluti che ella mi
inviava.
Voglia, caro Schanzer, ricordarmi al comm. Centurini e mi
creda sempre
Suo aff.mo G. Saredo
Roma, 30 Agosto 1899.
Tanto questa lettera, che quella riportata nel testo a p. 186
me le favorì gentilmente l'on. Schanzer.
____________________________
SAREDO AL SENATO
Buoni rapporti, quasi identici a quelli di De Pretis con
Saredo, esistettero fra quest'ultimo ed il palermitano Marchese Antonio
Starabba di Rudinì, che fu più volte Ministro e Capo del Ministero.
Da costui pure ricevette il nostro protagonista delicate
incombenze e mandati e veniva spesso sollecitato per consultazioni,
pareri, preparazioni di progetti di legge ecc.; (1) e quanta fosse la loro
intimità si manifesta dal tono del brano che qui riferisco, stralciandolo da
un biglietto che il Di Rudinì, presidente del Gabinetto, inviò a Saredo alla
vigilia d'un voto di fiducia del Parlamento.
|
Il marchese Antonio Starrabba di Rudinì
fu uomo politico di primissimo piano nei primi decenni dopo l’Unità Ricoprì
la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d’Italia ma fu
anche imprenditore agricolo avveduto e lungimirante che investì molte
risorse finanziarie nell’ammodernamento dei propri vigneti di contrada
Bimmisca e Sajazza e nella costruzione del “moderno” stabilimento enologico
a Marzamemi, in contrada Lettiera.
Contrastò la fillossera abbattutasi in Sicilia intorno al 1885, sostenendo,
a seguito delle scoperte agronomiche, la costituzione dei vivai per la
distribuzione delle talee di vitigni americani e la razionalizzazione e
modernizzazione nei sistemi di produzione vinicola.
A Pachino, a cento anni dalla scomparsa del
marchese, non rimane quasi nulla degli immobili della famiglia Di Rudinì:
l’antico palazzo Starrabba, poi sede del Palazzo Comunale, è stato abbattuto
oltre venti anni fa così come il palazzo Rudinì di Piazza Vittorio Emanuele
dove il marchese abitava durante i suoi lunghi soggiorni a Pachino.
Rimane solo lo stabilimento enologico di
contrada Lettiera a Marzamemi, acquistato dal Comune che ne ha avviato
l’opera di recupero, mediante un finanziamento europeo, per destinarvi un
Eco-museo.
http://www.siracusanews.it/node/4695
|
Caro amico,
Se non mi ammazzeranno sabato, ella potrebbe Venire a
colazione da me domenica, alla mezza. Dico così per celia, perchè, anche
quando fossi morto, mi resterebbe tanta vita che basti per passare un'ora
d'affettuoso colloquio con lei.
..................................................
Di Rudinì
E l'uomo politico palermitano, cui non latevano le doti e la
tempra del savonese, non tentennò nel 1891 - la prima volta che impugnò le
redini del Governo - ad includere il nome di Saredo nella lista dei
candidati al Senato ed a fargli conferire, in quello stesso anno, dal Re
Umberto I il laticlavio.
Da due altre lettere possedute dalla March. Marieni,
comprovanti pur esse lo spirito di intesa e collaborazione dei due
personaggi, scaturisce già limpidamente la misura dell' attività e influenza
di Saredo nel primo ramo del Parlamento.
In una del 20 agosto 1891, Rudinì raccomandava all'amico,
facente parte della Commissione per il Palazzo di Giustizia, che
s'ingegnasse a mandare le cose alle Calende greche, per non impegnare il
Ministero in una spesa di molti milioni.
Nell'altra, in data 18 febbraio 1898, lo pregava di
sollecitare la deliberazione dell'ufficio centrale del Senato sul disegno
di legge per lo scioglimento dei consigli comunali.
Ma se Saredo largheggiò di dottrine e cooperò generosamente
col Marchese Starabba, non gli risparmiò critiche e appunti, proprio come
aveva agito con Agostino De Pretis. e - per usare le parole del senatore
Crispolti - «quantunque amico di Di Rudinì, Saredo fu uno dei principali
censori di quello scetticismo ostentato con cui il Marchese Di Rudinì, a un
certo punto del suo ministero lasciò che tutto andasse a rotoli e
s'insediassero nell'amministrazione abusi più sconci di quelli che si
fossero veduti nei peggiori periodi».
_________________________
NOTE
1) Dalla citazione di queste due lettere, che scelgo tra
molte, il lettore, si renderà conto del come Di Rudinì si valeva dell'opera
di Saredo.
Il 25 Marzo 1892 il Presidente dei Ministri scriveva al
grande Savonese pregandolo di accelerare gli studi di progetti affidatigli,
volendo dare stabile assetto alle finanze
statali. E il 24 Novembre 1896 gli
raccomandava lo studio del disegno d legge per il decentramento.
__________________________________
RINUNZIA ALLA CARICA DI MINISTRO
In un precedente capitolo, accennai di sfuggita all'offerta,
fatta da Rudinì a Saredo, del Ministero di Grazia e Giustizia.
Consimile offerta gliela ripetè Francesco Crispi due volte,
ma Saredo ricusò sempre di fare il Ministro. E per quale ragione? Per una
diversità di vedute, tra lui e gli offerenti, circa la politica
ecclesiastica, come lo confesserà egli stesso scrivendo ad Agostino Cortese.
(1)
Ma se rifuggì - tre volte almeno - dalla carica di Ministro,
non economizzò tuttavia, specie con De Pretis e Di Rudinì, di consigli e di
indicazioni di individui per la formazione dei Ministeri; e tanto meno si
astenne, da senatore, di coadiuvare Ministri e personalità politiche, nei
punti in cui
 collimavano le sue colle loro aspirazioni. collimavano le sue colle loro aspirazioni.
Non s'intese molto con
Pelloux e
Zanardelli. Quest'ultimo
però aveva grande stima di lui, come rilevasi dalle parole seguenti,
contenute in una lettera di Zanardelli, presidente allora del Gabinetto.
Caro ed illustre amico,
Nessun suffragio poteva essermi caro e prezioso quanto il
suo, in una questione in cui ella è stato a tutti di guida. Di tale
suffragio è quindi altamente orgoglioso il tutto suo
Zanardelli
14 Dicembre 1901.
__________________________
NOTE
( 1 ) Lo scritto cui alludo lo pubblicherò nel capitolo Saredo e la sua
Città.
__________________________
CONTEGNO VERSO GIOLITTI
 Il nome di
Giolitti esercitò costantemente un'azione
ripulsiva sull'animo di Saredo. Il nome di
Giolitti esercitò costantemente un'azione
ripulsiva sull'animo di Saredo.
ITALIANI ALLO
SPECCHIO
L' abominevole
Tanlongo e il crac della Banca Romana
«Non è stato donnaiolo, non ha mai giocato, è
agli antipodi di ogni eleganza, la sua frugalità rassomiglia da vicino all'
avarizia...». Così veniva
descritto sul Corriere della Sera del 20-21 gennaio 1893 il settantatreenne
Bernardo Tanlongo, banchiere abominevole ma romanissimo. Nella sua
vecchia palandrana tra i saloni della sua banca, dove dalle sedie di cuoio
usciva la stoppa dell' imbottitura, egli era per tutti l' affannato Sor
Bernà. Cresciuto nella Roma del Papa Re e reso ancor più potente dagli
imbrogli edili di Roma capitale, aveva fronte vasta e la barba bianca,
venerabile come quella dei vecchi di Omero. Ma la sua maniera di estrarre
dai cassetti pratiche e lettere di cui parlare davanti a chi gli chiedeva i
soldi era solerte come quella dei preti della Curia. Gli stessi che serviva
ragazzino prima ancora che parlassero e per i quali, ventinovenne, era
evoluto da garzone a spia dei francesi nella Roma di Garibaldi. Non era
affatto un venale, ma piuttosto aveva inteso che i sederi delle puttane che
scrutava in gioventù pei cardinali, le lettere, le smorfie d' odio che
carpiva in un viso erano la segreta materia del denaro. Dunque era leale ai
gesuiti ma anche alle Logge, giacché le diversità di idee o di partito gli
parevano del tutto insignificanti. Seduto con la sciarpa nera sulle gambe,
davanti alla dama o all' appaltatore che contorto dai complimenti falsi
chiedeva denaro, lui vedeva cosa erano i soldi: il comando richiesto dalla
vanità universale. Potere che i vizi davano più delle virtù; vanità che
circola sempre senza requie. La vanità era il fiume torbido che sfociava nel
mare delle scadenze, che lui paterno, dunque avaro, doveva regolare: «Quando
mi farò il vestito nuovo io, allora ripareremo i salotti». Anche perciò
aggiustava volentieri i bilanci. Cos' erano l' avarizia dei numeri e le
somme, rispetto alla vanità umana? Col cassiere della Banca Romana e il
figlio, firmava in cantina banconote doppie. Ma non bastavano a colmare il
buco di cassa iperbolico, 28 milioni di lire, che il suo istituto, ancora
tra le banche d' emissione del Regno, aveva accumulato. Era però in quei
giorni sereno: la vecchia indagine sui conti della banca era finita nel
niente; e Giolitti, per i favori che il Sor Bernà aveva fatto a re Umberto e
alle sue amanti, l' aveva quasi nominato senatore. Si sentiva protetto dal
fatto che quasi non c' era un nome in vista che non fosse coinvolto. Tanto
che neppure si curava che prima di Natale in Parlamento s' erano date prove
pubbliche dei falsi in bilancio della Banca Romana. Così, quando alle sette
del 19 gennaio 1893 l' intendente di pubblica sicurezza arrivò per
arrestarlo, ne fu stralunato. Ma chiamò una carrozza; come sempre contrattò
un po' il prezzo col cocchiere; ieratico fece dirigere verso Regina Coeli.
Pareva che fosse lui ad accompagnare in carcere i gendarmi. Anche perché la
plebe della Suburra plaudì al suo passaggio, ricevendone in cambio sorrisi
bonari e dei sigari. Il Corriere della Sera ne diede notizia con
settentrionale sobrietà, come anche scrisse del banchiere Cuciniello
arrestato, mentre vestito da prete con due milioni e mezzo, scappava da casa
dell' amante. O del vecchio direttore del Banco di Sicilia assassinato a
coltellate per mancanza di rispetto alla mafia. Il tutto mentre, odiandosi
l' un l' altro, Crispi e Giolitti si davano in Parlamento a turno la colpa
di aver saputo e non detto. Parve palese a tutti gli onesti che Roma fosse
la cova d' ogni marciume: delle speculazioni edili e degli scandali bancari.
I plichi di lettere e ricevute, di cui si nutriva in ricatto reciproco la
politica italiana, temiamo non solo allora, erano del resto il mare ideale
in cui Tanlongo sapeva navigare. E il Corriere in una prima pagina
memorabile lo ricordò ai lettori. Sotto l' occhiello «un colloquio con
Tanlongo prima dell' arresto» riportò il chiaro avvertimento del Sor Bernà:
«Se mi si vuole chiamare responsabile di colpe non mie, io sarò costretto a
fare uno scandalo... (la faccia di Tanlongo in quel momento erasi accesa».
Più che accesa in effetti era rossa. Giacché il nostro soffriva non solo di
gotta per eccesso di abbacchi; ma anche di erisipela: malattia infettiva
contagiosa per cui la pelle infiammata tende al color porpora. Ma l' Italia
è nazione dove ricattato e ricattante si confondono, come mai altrove.
Crispi infatti teneva in pugno Tanlongo dal giugno del 1890, ovvero da
quando aveva la relazione della Commissione d' inchiesta sui suoi conti. E
in fase istruttoria del processo, richiesto sui soldi dati a Giolitti e le
carte da lui sequestrate, Tanlongo assecondò Crispi: «Lei non smentisce?».
Lui rispose: «Veggo che la verità si fa strada da sé, non ho più ragione di
negare: è vero». Ripagato e, scandalo nello scandalo, quindi assolto a fine
luglio 1894. Eppure quell' ammissione era il più perfetto scherzo da prete
fatto pure a Crispi. Nel plico che Giolitti aveva serbato dai cassetti del
banchiere c' erano anche le lettere di Lina Crispi al maggiordomo amante e
le tracce dei soldi pretesi da lei e suo marito. Il romanissimo banchiere
Bernardo Tanlongo fu il sommo genio, plebeo e pretesco, del ricatto per
azione fallace: «E se ben poi fallace la ritrova, pigliar non cessa una ed
un' altra nuova». (Ariosto, Orlando Furioso, canto XXXII, XV ottava).
|
L'uno e l'altro s'avversarono sempre,
seguendo sistemi e tattiche politiche diametralmente opposte.
Per Saredo,
il
giolittismo significava in politica ciò che significa in religione il
lassismo; e per il giolittismo, Saredo coi suoi principi rigidi, inculcanti
che il patrimonio pubblico si deve amministrare cogli stessi criteri con cui
i privati curano i loro interessi, Saredo, ripeto, era giudicato un
sognatore e poeta.
Una delle battaglie campali ingaggiata nella Camera alta dal
senatore savonese contro Giolitti fu quella sulla proposta di nomina a
membro del Senato del famoso
Bernardo Tanlongo, direttore della Banca
Romana.
Saredo, che era allora presidente della Commissione
senatoriale esaminatrice della lista dei nuovi candidati, s'oppose sì
energicamente alla convalidazione di Tanlongo da riportare piena vittoria.
Giolitti non dimenticò la stoccata e si asserisce tuttora che
sospirasse il momento di umiliare l'avversario, cercando qualche lato
debole della costui vita pubblica per attaccarlo, ma non lo scovò.
Le loro relazioni rimasero ordinariamente sì tese che, quando
Giolitti (Capo del Governo) doveva per motivi di ufficio conferire con
Saredo (presidente del Consiglio di Stato) non osava invitarlo al Ministero,
come avrebbero fatto liberamente De Pretis, Di Rudinì e Saracco, ma per
mezzo di lettere (1) o messi, lo pregava d'indicargli a che ora egli,
Giolitti, avrebbe potuto essere ricevuto a Palazzo Spada.
Di altri rapporti tra loro si parlerà nel capitolo
sull'inchiesta di Napoli.
________________________
NOTE
1) Due di queste lettere potei esaminarle io stesso.
_______________________
AZIONE IN SENATO
In Senato Saredo - come mi affermò S. Ecc. Boselli - si
distinse fra i più autorevoli per studio, diligenza e competenza,
dimostrandovi «quello stesso spirito pratico, che portò nella giurisprudenza
un'assenza assoluta di retorica; una grande conoscenza degli uomini singoli.»
(1)
Dotato di finezza d'intuito, fortezza e combattività
d'animo, a 70 anni affrontava le difficoltà e le questioni, come aveva
fatto a 20 anni, a Torino.
Non lo turbò mai il successo, nè i contrasti e le
lotte.
La sua influenza a Palazzo Madama s'estese vastissima sia negli
Uffici, che nelle Commissioni, di cui fu spesso presidente, e nel preparare
le sorti di votazioni.
Pronunziò elaborate ed applaudite relazioni su
disegni di legge e assunse sovente la paternità e responsabilità di
iniziative parlamentari. (2)
 A comprova della grande autorità esercitata dall'on. Saredo
in Senato, valga questa lettera, di S. E.
L. Luzzatti, che qui riproduco col
benigno consenso dei figli di questo celebre statista. A comprova della grande autorità esercitata dall'on. Saredo
in Senato, valga questa lettera, di S. E.
L. Luzzatti, che qui riproduco col
benigno consenso dei figli di questo celebre statista.
Illustre amico,
Perdonami l'insistenza, ma anche per preghiera di Rudmì, ti
esorto quanto più so e posso a recarti oggi alle tre nella Commissione del
Senato, che esamina il progetto delle Banche; è urgentissimo e se non si
nomina il relatore non se n'esce più.
C'è la fortuna che nella Commissione ce il Lampertico, il
relatore dell'altra volta, e v'è il fatto e la guarantigia che io introdussi
nella legge tutte le modifiche invocate dal Senato, migliorando le
convenzioni.
Mi affido a te.
Saluti affettuosissimi.
Luigi Luzzatti
__________________________
NOTE
1) Vedi art. del March. Crispolti nel «Cittadino» di Genova,
gennaio 1898,.
2) Queste notizie che attinsi a varie fonti, mi vennero tutte
riconfermate dall' on. Paolo Boselli.
3) Trascrivo qui volentieri anche questa lettera di S. Ecc. Luzzatti, perchè dimostra quanto l'eminente uomo di Stato stimasse Saredo.
«Mio illustre amico,
La tua approvazione così sollecita e decisiva è il nostro
orgoglio.
Tu sai a prova che cosa significhi, in Italia, lavorare per
la pura scienza: aiutaci, dacci qualche tuo lavoro sempre pregevolissimo;
aiutaci facendoci fare una cronaca
tecnica, potente del lavoro
costituzionale del Consiglio di Stato.
Ama il tuo amico».
Luigi Luzzatti
___________________________
UNA SUA BATTAGLIA
Chi fosse preso da bramosia di sfogliare i resoconti
parlamentari dal 1891 al 1902, s'imbatterebbe qua e là in importanti
discussioni, cui il senatore Saredo partecipò col suo caratteristico ligure
accento, ma più colla sua scienza e senso di praticità.
Certo, egli non ebbe la magica e travolgente parola d'un
tribuno, nè l'arte oratoria d'un Cicerone, ma i suoi discorsi sostanziosi e
forbiti attraevano l'attenzione dei colleghi e dell'aula. Ai discorsi dal seggio senatoriale egli preferiva
ordinariamente le conversazioni e le dispute nelle Commissioni, ove si
compieva un lavoro più persuasivo e fecondo.
Sua Ecc. Boselli mi delineò il suo grande concittadino, come
uno dei più abili manovratori di corridoio e dei più studiosi membri di
Commissioni.
Tuttavia, come dissi, Saredo non si astenne dal prendere
parte attiva alle sedute di Palazzo Madama: (1) e siccome di una di esse -
nella quale fece e sostenne proposte - ne parla egli stesso, (2) così
anch'io la citerò come prova e ricordo della sua combattività fra i «patres
conscripti».
La seduta cui alludo si tenne nel 1898 e Saredo vi propugnò
la necessità di rinnovare il Censimento nazionale.
Questo per l'art. 1 della legge 20 Giugno 1871 doveva farsi ogni 10 anni; ma, eseguito quello del 1881, la legge
era rimasta lettera morta, nonostante le reiterate promesse e speranze, che
dal 1891 al 1898 erano state a quando a quando affacciate di por mano a uno
nuovo corrispondente al secondo decennio.
Al Senato, Saredo presentò le ragioni dimostranti l'urgenza
di non procrastinare più oltre ad indire il censimento, che il paese e la
legge reclamavano da circa 7 anni; diede risalto agli inconvenienti che di
giorno in giorno si verificavano per l'applicazione di norme e regolamenti,
che ordinati, in base al vecchio censimento contrastavano col numero della
popolazione reale ; e lamentò che si dovesse ognora ricorrere a misure
provvisorie nei rapporti dei Comuni; nella classifica delle scuole, licei,
istituti; nelle facoltà delle amministrazioni locali ecc.
«Noi abbiamo - esclamò a un tratto - ventisei disposizioni
di legge, che si fondano per la loro applicazione sulle risultanze del
Censimento ufficiale e che rimangono inapplicate o male applicate, perchè
il Regno d' Italia con un bilancio che cammina verso i due miliardi non ha
ancora trovato la modesta somma necessaria per la spesa del Censimento che
dovrebbe essere decennale...». 
 Questa campagna, ch'egli aperse d'accordo col Bodio (3)
riscosse molte approvazioni in Senato e in Italia, specie negli ambienti
amministrativi. Questa campagna, ch'egli aperse d'accordo col Bodio (3)
riscosse molte approvazioni in Senato e in Italia, specie negli ambienti
amministrativi.
Al termine del discorso il Ministro delle Finanze, on. Carcano ed il Ministro dell' Agricoltura e Commercio, on.
Fortis diedero ampie
assicurazioni all'oratore che avrebbero affrettato l'esecuzione del
Censimento. Ma, dopo alcuni mesi, quei Ministri caddero e con essi si
seppellì anche il progetto del Censimento, il quale risorse e s'effettuò
solamente nel 1901.
_____________________
NOTE
1) Egli manifestò più volte la sua avversione al
parlamentarismo parolaio. Non condannò le discussioni, anche accese e
irrequiete dirette a chiarificare e sviscerare le
questioni, ma disapprovò
lo spirito di opposizione sistematica, che fin dai suoi tempi si praticava
da qualche parlamentare e che poi culminò nei famosi e deplorevoli
ostruzionismi dell'immediato dopo-guerra a Montecitorio.
2) Ne parla in una lettera a
Luigi Bodio, consigliere di
Stato e direttore della statistica generale del Regno.
La lettera, pubblicata nella rivista «La Legge», anno 1898,
tratta del Censimento decennale e dei suoi effetti giuridici secondo la
legislazione italiana.
3) Il Bodio, amicissimo di Saredo, nacque a Milano nel 1840.
Fu l'organizzatore sapiente dei servizi della statistica in Italia.
S'acquistò benemerenze per i suoi lavori sugli stati
civili e sulle
popolazioni.
Di lui così scrisse
Paul Leroy Beaulieu nella «Revue des deux
mondes» (15 ottobre 1897): «Le statistien qui a le plus complètement et
méthodiquement réunit les
documents relatifs aux mouvements de la population
dans les contrées civilisées est M. Bodio le très savant chef de la
statistique italienne; il les tient a jours; c' est a ses
tableaux qu' il
faut se reporter»
_______________________
PUBBLICISTA IMPENITENTE
Il titoletto, posto a capo di questo paragrafo, è quanto mai
appropriato, perchè il giovane savonese che, abbandonata la casa paterna,
incominciò a scrivere su giornali a Torino, continuò a pubblicare articoli
ed opere in tutte le sue altre residenze e non cessò che all'avvicinarsi
del proprio tramonto.
Gli si offersero prime palestre in giornalismo: il
«Fischietto», l'«Ausonia», il «Goffredo Mameli», il «Satana», le
«Scintille», la «Gazzetta del popolo» ed altri.
Il suo stile d'allora era vivo, mordace, satirico.
Pubblicò nella «Rivista contemporanea», nella «Rivista
illustrata» e in volumetti, novelle, studi storici, letterari, filosofici e
giuridici.
Diresse la notissima rivista «La Legge» e l'altra «Il
Conciliatore».
Appartenne alla redazione del «Diritto» e de «L' Italie». Sul
primo, giornale quotidiano, organo di De Pretis, collaborò lungamente con
Bargoni (1) e Marraini e nell'«Italie», ebbe molta riputazione, a causa
della sua grande conoscenza della lingua francese. E in qual conto fosse
tenuto, come giornalista, lo provano le testimonianze di tre eminenti uomini
pubblici.
Francesco Ferrara, che fu due volte ministro, gli
raccomandava nel 1872 di iniziare, nel «Diritto», una campagna a favore di
impianti ferroviari in Sicilia.
Paolo Onorato Vigliani, nel 1875, mentre reggeva il
Ministero di Grazia e Giustizia, lo pregava di continuare la campagna
diretta ad appoggiare il progetto di legge per l'istituzione d'una suprema
Corte di giustizia.
Quintino Sella, a sua volta, dopo avergli chiesto: «Avete
ancora qualche influenza nell' Italie?» l'incaricava di far inserire anche
in questo giornale i sunti delle sedute dell'
Accademia dei Lincei. (2)
Saredo scrisse inoltre sul «Fanfulla della Domenica» (3),
sulla «Nuova antologia», sulla «Minerva» e su diversi altri giornali o
periodici, nei quali riesce però oggi difficilissimo scoprire i suoi
scritti perchè abitualmente li pubblicava senza apporvi la firma.
I suoi scritti dell'età matura, ossia quelli da Consigliere
di Stato e da Senatore, dimettendo assai di vivacità e di stile mordace, non
perdettero nulla in vigoria, sodezza di argomenti e maestria di
ragionamento.
______________________
NOTE
1)
Angelo Bargoni, di cui si fece il nome altre volte in
questo volume, nacque a Cremona nel 1829. Nel 1860 fu segretario di De
Pretis, poi ministro con lui. Dal 1861 in poi
diresse il giornale il
«Diritto». Nominato senatore nel 1876, fu fatto ancora una volta ministro.
Morì nel 1901.
2) Gli originali delle lettere con cui Ferrara, Vigliani e Sella si rivolgono
a Saredo, sono conservati dalla Marchesa Marieni.
3) Il March. F. Crispolti afferma in una lettera alla Marchesa
Marieni d'aver fatta la conoscenza di
Ferdinando Martini, in seguito ad un
articolo di Saredo, comparso sul
«Fanfulla», e nel quale si trattava della
proibizione del vino alle donne presso i romani.
____________________________
UN'OPERA MONUMENTALE
E UN OPUSCOLO "DISCUSSO"
Elencherò, in appendice al presente libro, la serie dei
volumi e volumetti usciti dalla mente e vergati dalla mano di Giuseppe
Saredo.
Enumerandoli e riflettendo che l'uomo, che li compilò, viveva in
continua febbrile tensione per la scuola o per gli altri gravissimi uffici,
si è assaliti dal sospetto di trovarci dinanzi a un qualche prodigio.
Ma se rimando all'appendice suddetta i lettori vogliosi di
formarsi un'idea della produzione libraria del nostro scrittore, non posso
esimermi qui dal segnalar loro particolarmente due opere di Saredo: una
colossale che gli meritò calorosissime lodi e l'altra di piccolissima mole
che fu passionatamente discussa.
La prima racchiude il commento alla legge comunale e
provinciale; la seconda contiene lo studio sul voto obbligatorio.
|
Nel Discorso del 16 novembre 1887, affermò «Vi
sono riforme che il paese aspetta impaziente e che non potrebbero essere più
a lungo indugiate. Il mio Governo vi presenterà quindi leggi atte a ridurre
l’amministrazione centrale a più robusta unità, ad agevolarne l’azione con
una maggiore suddivisione di lavoro, a rendere inoltre questo lavoro più
diligente e spedito, mediante una equa determinazione dei diritti e dei
doveri dei pubblici funzionari». |
Nel 1887, pronunziando il discorso della Corona,
il Re
Umberto I annunziava la riforma della legge comunale e provinciale del 1865
e, nel novembre dello stesso anno, Francesco Crispi succeduto nella
presidenza del Consiglio dei Ministri a De Pretis, presentava il progetto
della riforma stessa, contenente 77 articoli. La promulgazione della detta riforma avvenne il 30 dicembre
del 1888.
Saredo, che durante i ministeri di De Pretis aveva esaminato
a fondo la materia e che aveva steso il progetto di legge, appena questa si
promulgò, diede alla luce il commento di essa.
E chi avrebbe potuto farlo con più scienza e competenza di
lui?
L'opera in 9 volumi apparve nel 1889 a Torino, coi tipi dell'
Unione tipografica editrice torinese e porta il titolo: La nuova legge
sull'amministrazione comunale e provinciale, commentata con la dottrina, la
legislazione comparata e la giurisprudenza, da G. Saredo.
Attorno ad essa, ch'era un commento, sbocciarono i fiori di
altri commenti, tutti di plauso ed encomio. Chi la definì «un'opera
monumentale» chi il «commento più completo e perfetto che potesse sperarsi»
chi «una pubblicazione di cui raramente sorse un'eguale» chi «più che un
commento, una successione di trattati in materia di Comune e Provincia
ecc.».
Anche ai dì nostri, essa è l'opera più completa su
quell'argomento e viene quotidianamente consultata e gli autori
specializzati in materia di amministrazioni locali, come il Mattirolo e il
Presutti e i modernissimi D' Alessio e La Torre frequentemente la citano
nei loro volumi.
Se Saredo non avesse fatto o scritto altro che il lavoro
sulla legge comunale e provinciale si sarebbe cinto di grandissima gloria.
L'altra pubblicazione - sul voto obbligatorio - comparve
prima sulle pagine de «La Legge» e poi si stampò in piccolo fascicolo; e se
diventò famosa non lo dovette tanto alla sua grossezza, quanto al clamore e
strascico che destò.
L'autore, tracciando quelle righe, aveva mirato ad uno scopo
plausibile, ma nella scelta dei mezzi per raggiungerlo non aveva, forse,
calcolato nella giusta misura i sentimenti e la suscettibilità della parte
cattolica della Nazione.
Egli - come la maggioranza dei liberali e conservatori
d'allora: eravamo al 1901 - fortemente impressionato dal costante
progredire dell'organizzazione socialista delle masse operaie e dal numero
dei deputati eletti da esse, aveva suggerito il voto obbligatorio come
potente rimedio ad arginare e controbilanciare la montante marea rossa.
Quand'egli scrisse il suo studio, l'astensione elettorale
stazionava sul 42 per cento e gli astenzionisti erano - secondo lui - nella
quasi totalità elementi d'ordine. Occorreva quindi spronarli, anzi,
obbligarli a recarsi alle urne.
|
NON EXPEDIT
(1874-1913). Formula latina (non conviene)
con cui la Santa sede il 10 settembre 1874 espresse parere negativo sulla
partecipazione dei cattolici italiani alle elezioni e in generale alla vita
politica dello stato. Il divieto, attenuato dall'enciclica di Pio X Il
fermo proposito (1905), che permise la partecipazione alle elezioni in
speciali circostanze riconosciute dai vescovi e fu attuata col patto
Gentiloni (1913), fu abolito nel 1919.
|
E, per obbligarli a votare, proponeva un complesso di pene
più o meno gravi contro i disertori delle elezioni. (1)
Il votare non sarebbe stato più un diritto, ma un grave
dovere: ed a provarlo, Saredo diceva che come lo Stato obbliga i cittadini a
servire da testimoni e giurati o li costringe a pagare le tasse, così ha
diritto di imporre ad essi il dovere del voto.
I cattolici insorsero, vedendo nel volumetto e nelle
proposte del Senatore e Presidente del Consiglio di Stato, un attentato al
«non expedit» ed alla loro libertà di mostrarsi ossequienti al Pontefice.
S'accesero ed arsero accanite polemiche, fra cui memorande quelle sostenute
dal foglio cattolico «La Voce della Verità» di Roma.
Saredo ebbe il consenso e l'approvazione di non poche tra le
più spiccate personalità del campo liberale e conservatore, ma il suo studio
e le sue proposte, col cessare delle polemiche, passarono alle biblioteche
per servire di documento sulle lotte che si pugnavano all'aurora del
ventesimo secolo; ed il voto obbligatorio restò un'aspirazione ideale. (2)
__________________________
NOTE
1) Eccone alcune: esporre in pubbliche tabelle i nomi dei non votanti;
togliere ad essi il diritto d'essere eletti; privarli di pubblici uffici,
anche dalle Congregazioni di Carità e
Camere di commercio; esclusione anche
dei figli e discendenti degli astenzionisti dal diritto di godere borse di
studio, e da quello di esenzione di tasse scolastiche, ecc.
2) Saredo ispirò e diresse la pubblicazione del «Digesto
italiano», che è una voluminosa enciclopedia di materia giuridica,
amministrativa e legale.
Esso fu definito ; «una biblioteca, un compendioso e ordinato
repertorio della legislazione e della giurisprudenza e della dottrina, così
riguardo all'adempimento dei pubblici
uffici, come nella gestione degli
interessi privati».
Il «Digesto» edito dall' U. T. E. T. iniziò le sue
pubblicazioni nel 1884 e Saredo ne presiedette il Consiglio d'
Amministrazione fino al 1902, anno in cui egli morì.
_______________________________
SUA FAMA ALL'ESTERO
Concludendo questo capitolo, ove trattai di Saredo
Consigliere di Stato e Senatore, aggiungerò che, come per la sua cultura,
doti personali e
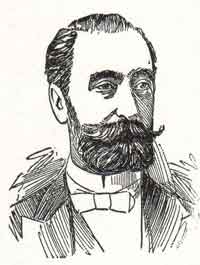 posizione sociale aveva contratto amicizie e relazioni con
una moltitudine di personalità di Roma e d' Italia, così per la sua fama,
sparsasi anche fuori dei confini del Regno, aveva allacciato ottimi rapporti
pure con personaggi stranieri non esclusi alcuni capi di Governo. posizione sociale aveva contratto amicizie e relazioni con
una moltitudine di personalità di Roma e d' Italia, così per la sua fama,
sparsasi anche fuori dei confini del Regno, aveva allacciato ottimi rapporti
pure con personaggi stranieri non esclusi alcuni capi di Governo.
Carnot,
presidente della Repubblica francese gli aveva scritto chiedendogli giudizi
sulla istituzione d'una scuola di scienza amministrativa, ch'egli, Carnot,
voleva fondare in Francia. Anche l'esigua repubblica di S. Marino si mise
in comunicazione col nostro uomo politico, sollecitandone suggerimenti e
norme per la riforma di Statuti e di Leggi.
Insignito inoltre di molte decorazioni, poteva indossarle con
nobile orgoglio, senza timore che chicchessia potesse rinfacciargli: «Non
le avete meritate». E se dal Re e dal Governo gli erano state affidate
cariche ed uffici onerati di responsabilità (1) egli li coperse tutti
degnamente, spiccandovi per senno, sapere e valore.
______________________
NOTE
1) Fece pure parte del Tribunale supremo di guerra e del
Contenzioso diplomatico
______________________
FONTI e LINKS di approfondimento
1. GIUSEPPE
SAREDO - BIOGRAFIA
2.
L'INSEGNAMENTO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO
3. IL
CREDO POLITICO
- SAREDO LIBERALE E MONARCHICO
4. TEORIE
FILOSOFICHE E RELIGIONE
5. L'INFUENZA POLITICA E LA QUESTIONE ROMANA
6. IL COMMISSARIAMENTO E L'INCHIESTA DI NAPOLI
7. SCHEDE DEI LICEI DI SAVONA
Inizio Pagina
|
 Relazioni più intime, come il lettore ricorderà, lo strinsero a Mamiani,
Minghetti, Brofferio, Villa, Sella, Correnti, Rattazzi, Ferrara ecc.
Relazioni più intime, come il lettore ricorderà, lo strinsero a Mamiani,
Minghetti, Brofferio, Villa, Sella, Correnti, Rattazzi, Ferrara ecc. Il 27
novembre 1873, il MINGHETTI fece l'esposizione finanziaria, in cui dichiarò
che il disavanzo del 1874 sarebbe stato di 130 milioni, cinquanta dei quali,
e cioè quelli occorrenti per le costruzioni, si sarebbero potuti ricavare
con il credito. Per colmare il disavanzo degli altri 80 milioni il Minghetti
propose quattordici disegni di legge relativi alla tassa sui redditi di
ricchezza mobile, alla nullità degli atti non registrati, all'abolizione
della franchigia postale, all'estensione della privativa dei tabacchi in
Sicilia ecc.
Il 27
novembre 1873, il MINGHETTI fece l'esposizione finanziaria, in cui dichiarò
che il disavanzo del 1874 sarebbe stato di 130 milioni, cinquanta dei quali,
e cioè quelli occorrenti per le costruzioni, si sarebbero potuti ricavare
con il credito. Per colmare il disavanzo degli altri 80 milioni il Minghetti
propose quattordici disegni di legge relativi alla tassa sui redditi di
ricchezza mobile, alla nullità degli atti non registrati, all'abolizione
della franchigia postale, all'estensione della privativa dei tabacchi in
Sicilia ecc.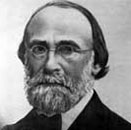 Trasferita
la capitale del Regno a Roma, i loro incontri divennero più frequenti,
perchè Saredo vi dimorava qual professore e De Pretis vi si recava qual
deputato; e da simili incontri, e dalla maggior consuetudine scaturì quella
profonda reciproca stima e leale amicizia, che fece ascendere Saredo a nuove
cariche e onori, e che fruttò a De Pretis, per lunghissimi anni, un
consigliere intelligente e fidato.
Trasferita
la capitale del Regno a Roma, i loro incontri divennero più frequenti,
perchè Saredo vi dimorava qual professore e De Pretis vi si recava qual
deputato; e da simili incontri, e dalla maggior consuetudine scaturì quella
profonda reciproca stima e leale amicizia, che fece ascendere Saredo a nuove
cariche e onori, e che fruttò a De Pretis, per lunghissimi anni, un
consigliere intelligente e fidato.
 E nel 1885, non essendo di molto mutate le condizioni in cui il Papato
trovavasi dal 1870, Leone XIII ribadiva i suoi lamenti e proteste «Mette il
colmo alla nostra amarezza la condizione, fatta qui in Roma, al Vicario dà
Gesù Cristo, la quale quanto più si protrae, tanto più diviene difficile e
dura».
E nel 1885, non essendo di molto mutate le condizioni in cui il Papato
trovavasi dal 1870, Leone XIII ribadiva i suoi lamenti e proteste «Mette il
colmo alla nostra amarezza la condizione, fatta qui in Roma, al Vicario dà
Gesù Cristo, la quale quanto più si protrae, tanto più diviene difficile e
dura». Dal
primo di essi (1) traspare che, nei primordi del suo insegnamento alle
Università, l'autore non nutriva soverchie simpatie per quell'alto Consesso,
istituito nel 1831 da
Dal
primo di essi (1) traspare che, nei primordi del suo insegnamento alle
Università, l'autore non nutriva soverchie simpatie per quell'alto Consesso,
istituito nel 1831 da
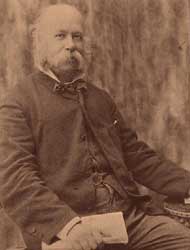
 «Saredo - ripeteva il barbiere - ci faceva lavorare, ma gli volevamo
bene ed eravamo contenti, perchè egli lavorava per il primo e doppiamente di
noi».
«Saredo - ripeteva il barbiere - ci faceva lavorare, ma gli volevamo
bene ed eravamo contenti, perchè egli lavorava per il primo e doppiamente di
noi». ed
ex Ministro del Regno, venne nominato a 28 anni referendario al Consiglio di
Stato ed assunto alla IV Sezione.
ed
ex Ministro del Regno, venne nominato a 28 anni referendario al Consiglio di
Stato ed assunto alla IV Sezione.
 collimavano le sue colle loro aspirazioni.
collimavano le sue colle loro aspirazioni.  Il nome di
Il nome di
 A comprova della grande autorità esercitata dall'on. Saredo
in Senato, valga questa lettera, di S. E.
A comprova della grande autorità esercitata dall'on. Saredo
in Senato, valga questa lettera, di S. E.


 Questa campagna, ch'egli aperse d'accordo col Bodio (3)
riscosse molte approvazioni in Senato e in Italia, specie negli ambienti
amministrativi.
Questa campagna, ch'egli aperse d'accordo col Bodio (3)
riscosse molte approvazioni in Senato e in Italia, specie negli ambienti
amministrativi.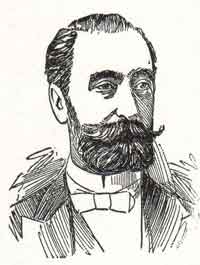 posizione sociale aveva contratto amicizie e relazioni con
una moltitudine di personalità di Roma e d' Italia, così per la sua fama,
sparsasi anche fuori dei confini del Regno, aveva allacciato ottimi rapporti
pure con personaggi stranieri non esclusi alcuni capi di Governo.
posizione sociale aveva contratto amicizie e relazioni con
una moltitudine di personalità di Roma e d' Italia, così per la sua fama,
sparsasi anche fuori dei confini del Regno, aveva allacciato ottimi rapporti
pure con personaggi stranieri non esclusi alcuni capi di Governo.